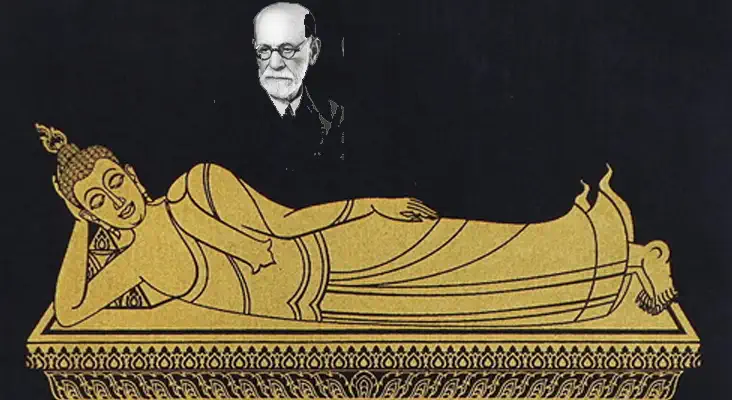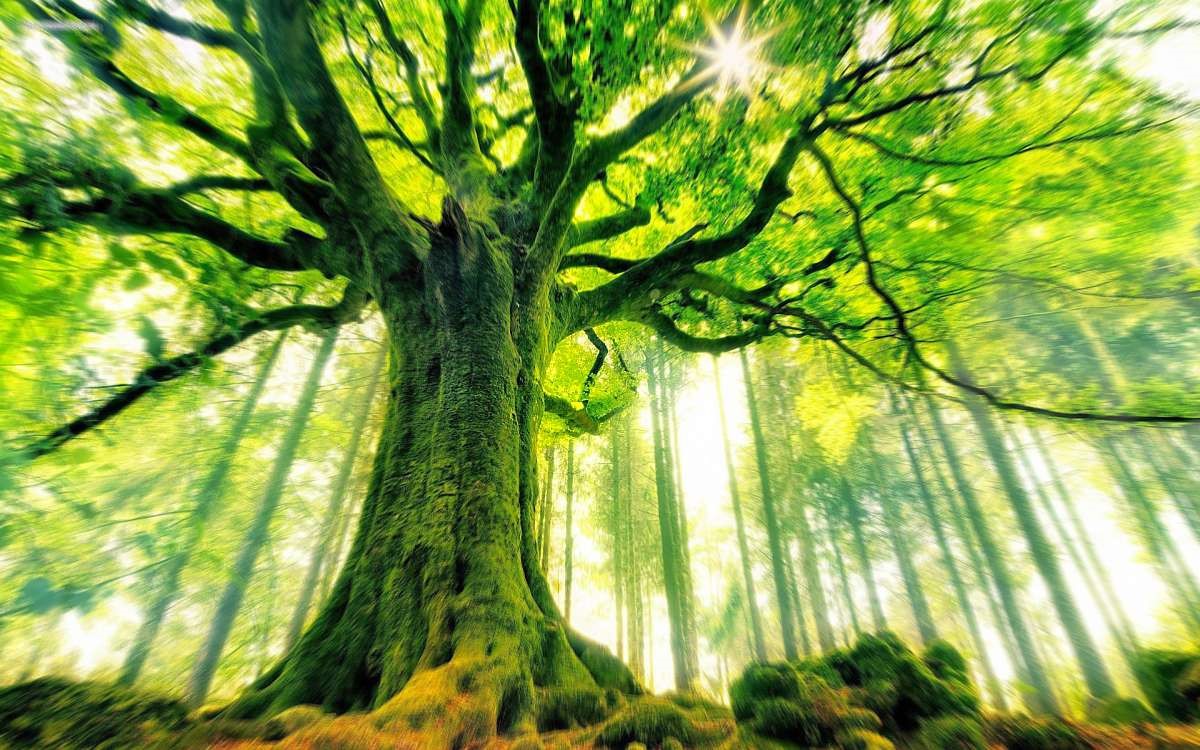“Sulla relazione madre/bambino”
da “XY. De l’identité masculine” di Elisabeth Badinter.
Traduzione libera di G.Visini
Elisabeth Badinter, laureata in filosofia, è docente di sociologia all’Ecole Polytechnique di Parigi. Di quest’autrice sono stati pubblicati in italiano “L’Uno e l’Altra, Sulle relazioni tra l’uomo e la donna” e “L’amore in più: storia dell’amore materno” editi da Longanesi.
———–
La fusione originaria
Durante i nove mesi della vita intrauterina, il feto e la madre formano un unico essere. Sappiamo da tempo che il benessere del bambino dipende dal benessere della madre. Stati depressivi, impressioni scioccanti o forti emozioni si ripercuotono su di lui. Ma non sappiamo ancora fino a che punto questa preistoria determini la vita dell’individuo. Lo sviluppo neurologico ancora incompleto permette di parlare di una specie di memoria in questi tempi delle caverne? I nove mesi passati nel seno materno non lasciano un’impronta femminile indelebile sul nascituro?
Alcuni psicologi hanno adottato il termine ‘imprinting’, usato nell’etologia, per descrivere l’influenza della madre sul suo piccolo e l’attaccamento di quest’ultimo a lei. Nelle prime settimane che seguono la nascita, la simbiosi madre/bambino continua per quanto lo permetta la vita extrauterina. Durante questi primi mesi, il neonato, che si trova nella dipendenza assoluta dalla madre, si differenzia da lei
molto lentamente. “Qui mette radici l’amore più potente e completo che sia concesso all’essere umano di conoscere”. Dal corpo a corpo al ‘tLte à tLte’, la relazione con la madre è “unica, incomparabile, inalterabile e diventa per i due sessi l’oggetto del primo e più potente amore, prototipo di tutte le successive relazioni d’amore” (Freud, Compendio di psicoanalisi). La madre non si limita a nutrire il bambino, lo cura e risveglia in lui molteplici sensazioni fisiche.
Quest’amore totale del bambino per la madre è stato celebrato migliaia di volte, soprattutto dagli scrittori di sesso maschile. Se l’amore materno può essere vissuto come un “impeto di felicità” dal neonato, può anche essere avvertito come una minaccia, se la madre non risponde in modo soddisfacente alla passione di un figlio troppo amorevole. La giusta misura nell’amore materno è ancora più importante se si rivolge al figlio maschio. Troppo amore gli impedirà di diventare un uomo, ma poco amore rischia di renderlo malato.
Fin dalla nascita, il neonato maschio è naturalmente in uno stato di passività primaria, dipende totalmente da colei che lo nutre. Già Groddeck notava che “durante la poppata, la madre è l’uomo che dà; il bambino è la donna che riceve” (Il libro dell’Es). Questa iniziale relazione erotica insegna al bambino il nirvana della dipendenza passiva e lascerà delle tracce indelebili nella psiche dell’adulto. Ma le conseguenze di questa esperienza non sono le stesse per il bambino e per la bambina. Per la bambina si tratta della base dell’identificazione con il suo proprio sesso, mentre per il maschietto è un’inversione dei ruoli che si presenteranno successivamente. Per diventare un uomo dovrà imparare a differenziarsi dalla madre e a rimuovere nel profondo di se stesso quella passività deliziosa in cui era fuso con lei. Il legame erotico tra la madre e il bambino non si limita alla soddisfazione orale. E’ lei che attraverso le sue cure risveglia la sensualità del figlio, lo inizia al piacere e gli insegna ad amare il suo corpo. La buona madre è naturalmente incestuosa e pedofila. Nessuno si sognerebbe di lamentarsene, ma tutti vogliono dimenticarlo, compresi la madre e il figlio. Normalmente, lo sviluppo motorio e psichico del bambino permette una progressiva separazione. Ma quando l’amore materno è troppo potente, troppo gratificante, perché il bambino dovrebbe uscire da questa diade deliziosa? Se, invece, quest’amore totale non è stato reciproco, il bambino passerà il resto della sua vita a cercarlo e a soffrire.
E’ nella natura dell’essere umano (maschio o femmina) cominciare la propria vita in una relazione amorosa passiva e trovarvi il piacere necessario per continuare poi a crescere e svilupparsi in seguito. Fino ad oggi, abbiamo pensato che spettasse solo alla madre incarnare il polo amoroso. Se è impensabile che lei cessi di esserlo, non è sicuro che il rapporto esclusivo con il figlio porti a quest’ultimo soltanto dei vantaggi.
La femminilità iniziale del bambino
Impregnato di ‘femminile’ durante tutta la vita intrauterina, poi identificato con la madre appena nato, il piccolo maschio non può svilupparsi che diventando il contrario di quello che era all’inizio. Questa protofemminilità del bebè umano è considerata in modo diverso dagli specialisti. Per alcuni favorisce lo sviluppo della figlia e ostacola quello del figlio. Per altri essa rappresenta un vantaggio per entrambi i sessi.
Il concetto di protofemminilità nel bambino è stato evocato per la prima volta da R. Stoller come risposta alle teorie di Freud sulla mascolinità innata. Così facendo Stoller ha operato una rivoluzione radicale: se Freud riconduceva la bisessualità originaria al primato della mascolinità (i due primi anni della vita), lo psichiatra e psicoanalista americano suggerisce invece che la bisessualità originaria porta al primato del femminile. Per Freud, che considera inesistente la protofemminilità, la bambina ha più ostacoli da superare rispetto al bambino. Pensava, infatti, che “la mascolinità fosse il modo originario, naturale, dell’identità di genere nei due sessi, e che fosse il risultato della prima relazione oggettuale eterosessuale del bambino con la madre, e della prima relazione omosessuale della figlia” (R. Stoller “Masculin ou féminin, PUF, 1989). Stoller rimprovera a Freud di aver trascurato il primo stadio della vita, caratterizzato dalla fusione che si produce nella simbiosi madre/bebè. Poiché le donne accettano la loro femminilità in una forma primaria e incontestata, la loro identità di genere è più saldamente radicata in rapporto agli uomini. Questa identificazione preverbale che potenzia la creazione della loro femminilità diventa nei bambini maschi un ostacolo da superare.
Se il bambino e la bambina devono passare entrambi per le stesse tappe di separazione e individuazione (Cf. i lavori di M. Mahler), il maschio incontra delle difficoltà ignorate dall’altro sesso. Lo studio dei transessuali maschi rivela a Stoller i pericoli di una simbiosi eccessiva tra il figlio e la madre. “Più una madre prolunga questa simbiosi – relativamente normale nelle prime settimane o nei primi mesi – più la femminilità rischia allora di infiltrare l’identità di genere.” (R. Stoller). Poiché questo processo lo ritroviamo pur con minor incidenza nella maggior parte delle relazioni madre/figlio, continua Stoller, è probabile che sia da ricercare qui l’origine della paura dell’omosessualità, più pronunciata negli uomini che nelle donne; come pure “l’origine di ciò che chiamiamo mascolinità, cioè la preoccupazione di essere forti, indipendenti, duri, crudeli, poligami, misogini e perversi”. Solo se il bambino riesce a separarsi senza problemi dalla femminilità e dalla ‘femminità’ della madre, potrà sviluppare “quell’identità di genere più tardiva che chiamiamo mascolinità. Allora vedrà la madre come oggetto separato e eterosessuale che potrà desiderare”. (Stoller).
No si potrebbe dire meglio: la mascolinità è seconda e “da creare”. Essa può essere messa a rischio dall’unione primaria e profonda con la madre.
Mentre la relazione omosessuale madre/figlia dei primi mesi non può che far aumentare nella figlia il sentimento di identità, il bambino piccolo dovrà fare di tutto per stroncare le sue pulsioni protofemminili. Il comportamento che le società definiscono come convenientemente maschili è fatto di manovre di difesa: paura delle donne, paura di mostrare qualche tratto femminile, includendo le forme di tenerezza, di passività o di cura prodigata agli altri e, naturalmente, paura di essere desiderato da un altro uomo. Da tutte queste paure, Stoller deduce gli atteggiamenti dell’uomo ordinario: “Essere rude, arrogante, guerresco; maltrattare e idealizzare le donne; ricercare soltanto l’amicizia degli uomini, ma, anche, detestare gli omosessuali; parlare in modo volgare; denigrare le occupazioni delle donne. Il primo dovere dell’uomo è: non essere una donna.”
Se la femminilità iniziale è concepita da Stoller come un handicap, alcune donne psicologhe la ritengono un grande vantaggio per i bambini. La simbiosi materna è benefica per entrambi i sessi perché è l’origine del sentimento che porta a prendersi cura degli altri, della tenerezza e dell’attaccamento negli uomini adulti. E’ associata a comportamenti positivi d calorosi (Miriam M. Johnson, Strong Mothers, Weak Wifes, 1988) che sono il miele delle relazioni umane posteriori. Se il bambino ha la sfortuna di avere una madre “fredda”, sarà incapace, da adulto, di esprimere questi sentimenti elementari e proverà spesso un odio inestinguibile per sé e per le donne.
Margaret Mitscherlich va ancora oltre sostenendo che la nostra società domanda troppo presto al bambino di staccarsi dalla madre e di adottare un comportamento maschile. E’ grazie all’identificazione con la persona che nutre – di solito la madre – che i bambini superano l’angoscia e lo sconforto. Interiorizzano i comportamenti della madre che consola e tranquillizza e sono in grado di vincere il loro odio per il fratello minore verso il quale si sentiranno, in parte, come una madre. (Helga Dierichs e M. Mitscherlich, Des Hommes, 1983). Phillis Chelser (La M>le donne, 1983) parla di quei bambini strappati troppo presto alle cure materne come “esseri dematrizzati”. Per questi autori la relazione primaria con la madre è la condizione stessa dell’identità umana del maschio. Se questa relazione non è buona o se l’identificazione non è possibile, il bambino avrà difficoltà a diventare un maschio umano.
Una della conseguenze di questo interesse portato alla relazione simbiotica tra madre e figlio è il fatto di riconoscere un’importanza del tutto nuova alla fase pre-edipica. Freud l’aveva evocata tardivamente (in Nuove conferenze sulla psicoanalisi, 1931) a proposito della specificità della sessualità femminile. Vedeva nella “fissazione alla madre”, la preistoria necessaria della costituzione della femminilità nella bambina. Invece, parla poco di questa fase nel bambino: “Esiste, ma è meno lunga, meno ricca di conseguenze e più difficile da differenziare dall’amore edipico, dal momento che l’oggetto rimane lo stesso.” Sono Mélanie Klein e i suoi eredi angloamericani che illuminato questo periodo arcaico, in particolare quelli che si sono interessati alla formazione dell’identità maschile. Nel 1967, lo psicoanalista Ralph Greenson, che lavorava con Stoller sui transessuali, attira l’attenzione, in una comunicazione al 25° Congresso di Psicoanalisi, sull’importanza per il bambino di “disidentificarsi” dalla madre.
Per i psicoanalisti americani, la tappa edipica è generalmente meno pericolosa per il maschietto della fase pre-edipica, poiché il principale pericolo per lui non è tanto la paura della castrazione paterna quanto il sentimento ambivalente fatto di desiderio e di paura nei confronti della madre: il desiderio radicato di ritornare alla simbiosi materna e la paura di restaurare questa unità arcaica. È dalla risoluzione di questo conflitto che dipende la costituzione dell’identità maschile.
Il bambino nell’universo materno
La durata della simbiosi madre/figlio varia grandemente da un’epoca all’altra e, oggi, da una cultura all’altra. Più la simbiosi è lunga, intima e fonte di piacere reciproco, più è grande la possibilità che il bambino divenga femminile. “Questo effetto persisterà se il padre non interrompe la fusione in modo sia quantitativo che qualitativo.” (Stoller).
Questo non riguarda le nostre società industriali odierne. Poiché le donne hanno completamente trasformato il loro stile di vita, la simbiosi con i loro figli è diventata molto più breve. L’aumento costante del numero di madri che lavorano fuori casa limita la possibilità dell’allattamento, e con esso il prolungamento del corpo a corpo fusionale con il bebè. Al di là delle necessità economiche, è sempre meno evidente che esse desiderino questo prolungamento oltre i primi mesi che seguono la nascita. L’interesse per il bambino entra in competizione con altri interessi, professionali, culturali e sociali. Il bambino conosce molto presto la frustrazione della separazione, un cibo diverso e altri volti che non sono quello della madre. Per la madri che si consacrano interamente al loro piccolo, arriva la scuola a segnare il tempo della separazione. Sebbene in Francia non sia obbligatoria prima dei sei anni, l’uso vuole che vi si mandino i bambini già verso i tre anni o anche prima…Guarda caso proprio alla fine del periodo pre-edipico!
All’altro capo del mondo, le madri delle numerose tribù guerriere della Nuova Guinea (Cf. i lavori di M. Godelier e G.H. Herdt) si comportano in modo del tutto diverso. Innanzi tutto i tabù post partum (cioè il fatto che le attività sessuali siano proibite alla coppia fino al secondo anno di età del neonato) contribuiscono a rafforzare la diade madre/figlio. Il novello padre Sambia o Buruya deve evitare la madre e il bambino, innanzi tutto perché sia l’una che l’altro possono contaminarlo a causa degli elementi inquinanti del parto, e poi perché l’eccitazione sessuale prodotta dalla vista dell’allattamento potrebbe portarlo a rompere il tabù, causando in questo modo la malattia o la morte del neonato.
Fino allo svezzamento, il padre vede poco suo figlio. I Sambia hanno la tendenza a considerare il bambino un prolungamento del corpo della madre durante i primi nove mesi. Il bambino ha accesso al seno della madre senza restrizioni, a volte fino ai tre anni di età. Vive nelle sue braccia, a contatto di pelle, e dorme nudo con lei fino allo svezzamento. Dopo, sia il bambino che la bambina dormono separati dalla madre, ma a una distanza di trenta o sessanta centimetri da lei. Con il passare del tempo, i bambini maschi sono incoraggiati dai genitori a dormire un po’ più lontano dalle loro madri, ma non ancora nello “spazio maschile” della casa. Nonostante un contatto più frequente con il padre, i bambini continuano a vivere con la madre e i fratelli e sorelle fino ai sette o dieci anni.
Le tribù della Nuova Guinea coscienti dei pericoli di “femminilizzazione” del bambino, procedono a riti di iniziazione generalmente molto lunghi e traumatizzanti, tenuto conto dell’intenso legame madre/figlio che bisogna sciogliere. Vedremo più avanti come il rituale separa brutalmente il bambino dalla madre, per strapparlo al suo abbraccio amoroso.
A un livello minore, il momismo americano, osservato fin dal XIX° secolo con l’inizio della società industriale, è un altro tipo di fusione prolungata con la madre. Al corpo a corpo, segue un tLte à tLte con una donna onnipotente che pone non pochi problemi ai figli. Poiché i padri sono assenti, “i figli soffocano sotto l’amore protettivo delle madri” (Joe I. Dubbert, A Man’s Place). L’assenza di identificazione maschile si fa sentire crudelmente. Soprattutto quando i costumi permettono che una madre vesta il suo bambino con abiti femminili fino ai sei anni, come è stato il caso di Franklin D. Roosevelt, e che gli lasci crescere lunghi boccoli… Alcuni bambini non si riprenderanno più, come Ernest Hemingway che ha sofferto per tutta la vita di disturbi dell’identità sessuale. Secondo il suo biografo, Kenneth Lynn, la madre, personalità potente, autoritaria e virile, lo trattò per molti anni come una bambina. Non soltanto lo vestiva e pettinava come se fosse la sorella gemella della figlia maggiore, ma aveva creato per il piccolo Ernest una deliziosa situazione di dipendenza fin dal primo strillo. Per sei mesi, egli dormiva nel letto della madre dove era autorizzato ad accarezzarle il viso, e stringersi a lei e a nutrirsi a volontà dalla suo seno opulento. “E soddisfatto di dormire con la mamma e succhia il latte tutta la notte”, scrive contenta sul suo diario.
Sebbene il padre fosse un uomo debole, senza autorità e profondamente nevrotico (si tolse la vitaidò nel 1928 con un colpo di rivoltella alla tempia), si deve ai suoi interventi se Hemingway non divenne ancor più disturbato. Da bambino aveva avuto con lui un vero legame affettivo: il padre, alla ricerca di tutto ciò che potesse confortare la virilità del figlio, lo portava con sé a caccia e a pesca fin dall’età di tre anni. Ma se il padre ha potuto evitare il peggio, non era abbastanza forte da liberarlo completamente dall’influenza materna, essendo lui stesso una vittima castrata dalla moglie. Per resistere alla madre, Ernest Hemingway non ebbe altra alternativa che quella di fuggire e di odiarla. “come mai un uomo, secondo il suo vecchio amico Dos Passos, ha veramente odiato sua madre”. Perseguitato per tutta la vita da lei e da un profondo desiderio di femminilità, da adulto non utilizzerà per definirla altre parole se non: “Quella baldracca…”
Tagliare nel vivo
o il necessario tradimento della madre
La caratteristica propria dell’identità maschile (all’opposto dell’identità femminile) si trova nella tappa di differenziazione dal femminile materno, condizione sine qua non del sentimento di appartenenza al gruppo degli uomini. La loro somiglianza e la loro solidarietà si costruisce con il tenere a distanza le donne e, innanzi tutto, prima tra tutte, la madre. Alcuni parlano di tradimento, altri di morte simbolica. Un’eventualità potrebbe essere che, nell’orda primitiva evocata da Freud, il matricidio abbia preceduto il parricidio.
Come a ragione sostiene Hermann Burger (in La mère artificielle), ogni uomo si confronta con questo problema: “Da una parte, procedere attivamente contro la madre; dall’altra soffrire passivamente a causa sua…Dobbiamo ucciderla e morire di lei…Così facendo l’uomo deve stare attento a non ferire la sua anima femminile.”
Il dolore della separazione
Rileggendo La passeggiata al faro di Virginia Woolf, Pierre Bourdieu evoca “la metafora del coltello o della lama che colloca il ruolo maschile dalla parte della rottura, della violenza, dell’uccisione, cioè dell’ordine culturale costruito contro la fusione originaria con la natura materna”.
Il coltello o la lama non alludono soltanto al taglio del cordone ombelicale che vale per i due sessi, ma parlano anche di questa seconda separazione dal femminile materno che è rappresentata dalla circoncisione. Praticata qualche giorno dopo la nascita, verso i tre, quattro anni o nell’adolescenza, essa ha sempre l’obiettivo di rinforzare la mascolinità del bambino o del ragazzo. Poiché costituisce una castrazione simbolica, la circoncisione ha interessato molti psicoanalisti. Theodor Reik, Géza Roheim, Herman Numberg o Bruno Bettelheim hanno mostrato che essa staccava il bambino dalla madre e lo introduceva nella comunità degli uomini. Inoltre, sottolinea l’importanza del pene.
Bettelheim nota che per i ragazzi, “l’esibizione del glande liberato dal prepuzio fa parte degli sforzi compiuti per affermare la loro virilità. Su questo punto, il ragazzo circonciso ha una netta superiorità: il suo glande è visibile, cosa che è spesso considerata come il segno di una virilità più salda” (Les blessures symboliques, 1971). Numberg insiste sul fantasma della rinascita che accompagna la circoncisione: il bambino circonciso rinasce senza prepuzio e così è un uomo (Problems of bisexuality as reflected in circoncision, 1949). Agli occhi di Groddeck, la circoncisione degli ebrei è una forma di rimozione della bisessualità, cosa che li distingue da tutti gli altri esseri umani: “Il prepuzio è rimosso per eliminare ogni traccia di femminilità dall’insegna della mascolinità; infatti il prepuzio è femminile, è la vagina nella quale è protetto il glande maschile… presso gli ebrei, se essi tagliano il prepuzio… eliminano la bisessualità dell’uomo, tolgono al maschile il carattere femminile. Rinunciano così, a favore della divinità bisessuale, alla loro similitudine divina innata. Attraverso la circoncisione, l’ebreo diventa soltanto un uomo.” (in Nouvelle revue di psychanalyse, 1973).
La circoncisione, rinuncia simbolica alla bisessualità divina, è insieme il segno della finitezza umana e di quella maschile. Praticata otto giorni dopo la nascita nella tradizione ebraica, interviene nel momento di più forte intensità della simbiosi madre/bambino. Appena nato, il bebè è ancora parte del corpo materno. Quando gli uomini arrivano per prendere il neonato e praticare la circoncisione, il messaggio trasmesso alla madre è che ormai il figlio appartiene a loro e non più a lei. La circoncisione ferisce il figlio e nello stesso tempo la madre che si sente amputata di una parte di se stessa. Per quanto dolorosa sia questa separazione “al coltello”, non è soltanto il segnale che la fusione materna deve finire, ma è anche il recupero simbolico del figlio da parte del padre, il primo atto della differenziazione sessuale.
I tre anni che seguono la nascita del bambino sono il periodo necessario per la separazione psichica del figlio dalla madre. Per fare questo deve rafforzare i confini tra se stesso e lei, “mettere fine al loro primo amore e al loro sentimento di unione empatica” (Carol Gilligan, In different voice, 1982). Il bambino deve sviluppare un’identità maschile mentre è assente una relazione stretta e continua con il padre, simmetrica a quella che una figlia conosce con la madre. Nancy Chodorow constata che, mancando un’identificazione forte con un uomo, “i figli di padri assenti (tipici della famiglia contemporanea) elaborano un ideale di mascolinità attraverso l’identificazione con le immagini culturali di essa e scegliendo uomini famosi come modelli maschili” (The reproduction of mothering. Psychoanalysis and the sociology of gender, 1979). La grande difficoltà per loro consiste nell’operare una disidentificazione, con il seguito di negazione e di rifiuto del femminile, senza il sostegno effettivo di un modello positivo di identificazione. Questa è l’origine di un’identità maschile più negativa che positiva, che mette l’accento sulla differenziazione, sulla distanza rispetto agli altri e sul rifiuto della relazione affettiva. Mentre i processi di identificazione femminile sono relazionali, quelli maschili sono “opposizionali”.
Lillian Rubin, molto ispirata dai lavori della Chodorow, ha tratto le conseguenze di tutto questo per l’uomo adulto. Pensa che l’aggressività maschile verso le donne possa essere interpretata come una reazione a questa perdita precoce e al sentimento di tradimento che l’accompagna; il disprezzo per le donne viene dalla rottura interiore necessaria alla separazione dalla madre. Questo disprezzo, nella sua opinione, ha origine nella paura e non nell’arroganza, “la paura del bambino che è obbligato a respingere la presenza onnipotente della madre” (Des étrangers intimes, 1986).
Anche se rimossa, la simbiosi materna perseguita l’inconscio maschile. Poiché gli uomini sono stati allevati per millenni unicamente dalle donne, devono spendere ingenti quantità di energie per conservare i confini. Tenere le donne a distanza è il solo modo per salvare la virilità. Rousseau lo sapeva bene e infatti chiamava uomini e donne “a vivere abitualmente separati… Essi risentono come e più delle donne del loro troppo intimo commercio. Esse vi perdono i loro costumi, noi vi perdiamo i nostri costumi e insieme la nostra costituzione. Non volendo più soffrire la separazione, non potendo diventare uomini, le donne rendono noi donne” (Lettres à D’Alembert, 1758).
La mascolinità: una reazione, una protesta
L’uomo virile incarna l’attività. Ma quest’attività non è altro che la reazione alla passività e all’impotenza del neonato. Il monopolio dell’attività da parte degli uomini non viene da una necessità sociale. L’interiorizzazione delle norme della mascolinità esige un surplus di repressione dei desideri passivi, in particolare quelli di essere maternalizzati. La mascolinità che si costruisce inconsciamente nei primi anni di vita si rafforza in seguito fino a esplodere letteralmente nell’adolescenza. E’ quello il momento in cui la sofferenza e la paura della femminilità e della passività cominciano a diventare evidenti. La maggior parte dei giovani lotta contro questa sofferenza interiore rafforzando ancora di più i bastioni della mascolinità.
Questa reazione è una lunga battaglia che mette in gioco una formidabile ambivalenza. La paura della passività e della femminilità è tanto più forte quanto più lì si trovano i desideri più potenti e più rimossi dell’uomo. Il combattimento incessante non è mai vinto per sempre, poiché come si potrebbero rinnegare per sempre le reminiscenze dell’Eden? Se nella vita reale, gli uomini resistono bene o male al desiderio raramente dichiarato di regressione, questo può apparire allo scoperto nei romanzi. Molti sono gli scrittori che evocano la nostalgia del ventre materno. Le rLve du singe fou (di C. Frank, 1976) paragona gli uomini adulti a piccoli Peter Pan che rifiutano di crescere. In modo ancora più esplicito, l’autore evoca “l’adulto testardo che si ostina a voler passare per una piccola porta, dove, da bambino, passava … quest’orifizio (il sesso della madre) che non è attraversato che una sola volta e in un solo senso”. Stesso desiderio espresso nel superbo affresco di Günter Grass, Il rombo. Gli uomini sono soltanto bambini che sognano una madre con tre seni. “Hanno bisogno delle loro poppate quotidiane, anche i vecchietti tremanti…Con il seno, gli uomini sono sazi, soddisfatti, protetti. Non devono mai prendere decisioni… vivono esenti da responsabilità”. Lo stesso desiderio, ma questa volta represso, in La mère artificielle di Hermann Burger: “Al diavolo questi eterni piagnucolii di uomini-bebè afflitti da mammamnesi… che vorrebbero svignarsela nel ventre della madre. Mettiamo finalmente in campo la papàmnesi!…”
Philip Roth ha fatto di meglio: il suo eroe David Kepesh subisce una metamorfosi trasformandosi in un enorme seno di donna. Non potendone più della sua virilità e dell’incredibile controllo di sé che essa esige, cade in un delirio che l’autorizza a gustare tutti i piaceri derivanti da un’impotenza totale (Il seno). Desiderio di ritornare nel ventre materno o allo stato di lattante … queste prime ore della vita in cui il bambino è il seno. Al di fuori di questo delirio romantico, tutta l’opera di Philip Roth racconta la guerra spietata dell’adulto al bambino impotente e dipendente: “La voce dell’uomo rifiuta il bambino tentato dall’irresponsabilità.” (La mia vita di uomo).
Per potersi lasciare andare a questi fantasmi regressivi, è necessario aver preso qualche distanza dalle proprie angosce. Forse anche il fatto che oggi si rimettano in questione la mascolinità e la femminilità aiuta gli uomini a sciogliere il nodo della repressione che, ancora vent’anni fa, li soffocava. Ma non tutti sono capaci di questo sguardo lucido su se stessi. I più fragili, ma anche i più feriti, non possono mantenere la loro mascolinità e lottare contro il desiderio nostalgico del ventre materno se non odiando il sesso femminile. Ricordiamo il disgusto di Baudelaire: “Un’altra… piena di pus”.
…..
Rimane il fatto che dall’infanzia e fino all’età adulta, e talvolta per tutta la vita, la mascolinità è più una reazione che un’adesione. Il bambino si afferma opponendosi: non sono mia madre, non sono un bebè, non sono una femmina, proclama il suo inconscio. Secondo l’espressione di Alfred Adler, l’avvento della mascolinità passa per una protesta virile. Il termine ‘protesta’ evidenzia che si tratta dell’eliminazione di un dubbio. Si protesta la propria innocenza quando vi è il sospetto di colpevolezza. La si grida alto e forte per convincere gli altri che non siamo quello che ci sospettano di essere. Così, il bambino (e poi l’uomo) protesta la sua virilità perché rimane un sospetto di femminilità. Ma questa volta il dubbio viene più da se stesso che dagli altri. Deve convincersi della sua innocenza, cioè della sua autenticità maschile.
Questa protesta si rivolge innanzi tutto alla madre, e consta di tre affermazioni: Io non sono lei. Io non sono come lei. Io sono contro di lei.
Tradimento e uccisione della madre
La separazione dalla madre oscilla tra due temi complementari: il tradimento della madre amata (la buona madre) che perseguita un Philip Roth, e la liberazione dall’oppressione materna (la cattiva madre frustrante e onnipotente) che ossessiona in particolare gli scrittori di lingua tedesca contemporanei (G. Grass, M. Krüger, Th. Bernhard e molti altri). A seconda dell’immagine materna prevalente (anche se l’una non va senza l’altra) emerge più fortemente il senso di colpa o l’aggressività. Freud attribuiva all’uomo un “disprezzo normale” della donna a causa della mancanza del pene, ma Janine Chasseguet-Smirgel, più sottile del maestro, scopre “dietro il disprezzo dichiarato…un’imago materna potente, invidiata e terrificante”. Essa terrorizza perché simbolizza la morte, il ritorno indietro, l’essere aspirati da una matrice avida.
Gli psicologi hanno spesso evocato il tema del tradimento materno. L’uomo adulto diffiderebbe delle donne perché si ricorda della madre che ha tradito il suo amore, abbandonandolo a poco a poco al mondo degli uomini. Ma c’è un altro tradimento che appare in filigrana in tutta l’opera di Philip Roth: il tradimento della madre da parte del figlio. E’ questo per lui il vero scandalo, molto più che il fallocentrismo del maschio. Non si può essere un uomo senza tradire la madre, “tagliare i legami d’amore della propria infanzia”. La virilità, dice Roth, è: “Dire no alla propria madre, per poter dire no alle altre donne”. O ancora: “Essere niente, è essere il suo Philip (della madre), ma … la mia storia inizia e prende l’avvio grazie al fatto di essere il suo Roth (del padre)”. Portnoy, in Il lamento di Portnoy, consulta uno psicoanalista perché gli trasmetta la forza virile: “Mi renda forte, mi renda completo”. Detto altrimenti, mi aiuti a tradire mia madre. Si sente troppo colpevole verso di lei per osare uscire dalla sua orbita, dal suo corpo, e diventare un uomo. Adolescente, lei lo tratta sempre come il suo bebè e alla prima velleità di autonomia, lei piange… Tradirla significa senz’altro far esplodere le lacrime di lei, il senso di colpa, il terrore e le angosce di lui. Il dramma di Portnoy non si trova tanto nella onnipotenza materna e nell’impotenza paterna, quanto nel fatto che la madre lo considera come il suo “innamorato” e lui lo sa. Come sa che può pretendere di conservare questa posizione solo fintanto che rimarrà il suo bebè.
Risultato: a quattro anni, sapeva appena a che sesso apparteneva. Si ricorda che a nove anni, quando uno dei testicoli non era sceso, era stato preso da un’angoscia terribile: “E se in più cominciasse a crescermi il seno? E se il mio pene diventasse secco e friabile e si sbriciolasse nella mia mano mentre urino? Allora diventerei una bambina”. Bambina o bebè: questi sono gli ostacoli che il bambino deve togliere di mezzo per diventare un uomo. Nei due casi, si tratta di rompere con la madre. Ma come riuscirvi se lei minaccia di togliergli il suo amore e persino di castrarlo? Lei che gli insegnato a urinare in piedi “titillando il suo pisellino…”
………………………..
Il senso di colpa lascia il posto all’aggressività a e all’odio. Anche Philip Roth non vi sfugge. Si dibatte furiosamente contro l’onnipotenza materna che gli impedisce di crescere. Non avendo combattuto, ha perduto la sua virilità. Adulto, si sottomette a tutte le donne che ama: impotente, masochista, “riga dritto con loro come un gentile ragazzo senza difese”. E’ diventato “un lattante egomaniacale”, che non conosce che una sola difesa: ridurre tutte le donne “allo stato di oggetti masturbatori”. Altri scrittori esprimono più brutalmente il loro odio e la loro necessità di matricidio. G. Grass, ne Il Rombo, lo dice senza mezzi termini: l’atto virile per eccellenza è l’uccisione della madre. Senza questo atto fondatore che fa uscire un uomo dall’oscura preistoria del seno materno, la morte vince sulla vita.
La letteratura è ricca di denunce contro la madre. Una gara a chi grida e piange più forte. M. Krüger illustra il complesso materno dell’uomo del nostro tempo. L’uomo-bebè è malato di una simbiosi infernale: si sente un niente, uno straccio senza identità, divorato da una madre onnipotente e da donne carnefici (Perché io? E altri racconti). Peter Rosei evoca con orrore l’uomo impaurito come un bambino davanti alla dea-donna, autosufficiente e crudele. Non potendola uccidere, la feticizza, prende una parte e rifiuta la donna nella sua interezza. La donna-dea fa dei sortilegi: impedisce al figlio di crescere e lo rende impotente (H. Bürger, Saul Bellow, Pat Conroy, e altri ancora). Come un Portnoy nordico, nessuno meglio di Knut Faldbakken ha tracciato (in La seduzione e Il Monarca) il ritratto della madre onnipotente e del figlio eterno lattante, Il Monarca appunto (o il Bad Boy, titolo originale del libro norvegese): insofferente, apatico, senza identità, masochista, passivo, si disprezza perché ha paura di tutto, anche della sua ombra. Gli eroi dei romanzi di Faldbakken piangono come lattanti sulla loro impotenza e vivono episodi omosessuali. Solo il corpo di un altro uomo può rassicurare l’uomo-lattante, in preda a una profonda depressione.
Il romanzo maschile, da nord a sud e da est a ovest, ha fatto della madre castratrice e mortifera uno dei temi più trattati della letteratura contemporanea. Una gara a chi denuncerà con più forza queste donne “avvelenatrici di sollecitudine” che generano uomini-bebè. I padri, quando non sono morti, sono descritti come ombre senza consistenza: affettivamente assenti, miserabili, umiliati, disprezzati. Incapaci di strappare il figlio dalle grinfie amorose della madre. Risultato: i diversi eroi di questi romanzi ne escono molto male. Si è parlato di impotenza, depressione, episodi omosessuali, suicidio e follia, ma l’aggressività dell’uomo può anche rivolgersi all’esterno. Tratta le donne come oggetti usa e getta, diventa sadico o assassino. L’eroe di Roland Clément, in Fausse Note, invaso dall’amore simbiotico e sensuale della madre, diventa assassino di donne. Efebo biondo dal sesso incerto, infantile e femminile, finirà ucciso dalla madre che con questo gesto firmerà l’ultima protezione (contro la giustizia) e il possesso materno “antropofago”. Ci sono quelli che sognano di uccidere la madre per evacuare tutto l’odio accumulato e quelli che la uccidono davvero. L’affascinante figlio assassino di Ludovic Janvier (Monstre, va!) è una caricatura del maschio abortito: senza coraggio, collerico, dolce, molle, grosso, amante degli escrementi, ha sempre fatto finta di esistere. Parla di se stesso al femminile e d’altra parte somiglia a una donna, con seni e fianchi. Uccidendo la madre, spera di liberarsi dalla paura di esistere. Ma l’atto lo imprigiona. Evoca “la vischiosità dell’amore” e gioca con l’idea dell’uomo gravido che offrirebbe un “ambiente virile” al bebè maschio.
In verità, passato il momento opportuno, la rottura con la madre è impossibile senza un aiuto terapeutico. E anche così, la simbiosi prolungata lascia dei pesanti strascichi. Il fallimento della separazione provoca i peggiori disordini. Dalla transessualità alla psicosi (né proibizione dell’incesto, né castrazione paterna), passando per vari disturbi dell’identità e del comportamento: “mascolinità egemonica”, disprezzo delle donne, aggressività non canalizzata, “fame del padre”, ecc.
Tutto questo sembrerebbe dare ragione alle tribù della Nuova Guinea che temono l’influenza mortale delle madri sui figli. Poiché esse impediscono loro di crescere e diventare uomini, i maschi adulti devono strapparli alla loro cura nel modo più crudele.
Il bisogno vitale di differenziazione
La differenza tra i sessi è molto variabile da una società all’altra. Fortemente evidenziata o appena percettibile all’osservatore straniero (nelle nostre società, è a volte difficile distinguere un ragazzo da una ragazza), tardiva (Tahiti) o precoce (le società occidentali prima del 1900 per esempio), la differenziazione sessuale è un dato universale. E’ vero che le società si evolvono lentamente e che i media più popolari continuano a diffondere gli stereotipi maschili e femminili tradizionali. Ma è tempo di riconoscere che la spiegazione sociale non è sufficiente. Le resistenze sono anche psicologiche, e come tali, non aleatorie. Il bisogno di differenziarsi dall’altro sesso non è l’effetto dell’apprendimento, ma un bisogno arcaico. “La maggior parte delle società utilizzano il sesso e il genere come principale schema cognitivo per comprendere il loro ambiente. Le persone, gli oggetti, le idee sono comunemente classificati come maschi o femmine.” (Holly Devor, Gender Blending)
I bambini utilizzano questo schema cognitivo per comprendere il mondo, ma soprattutto per comprendere se stessi. L’atto del conoscere comincia con la distinzione e la classificazione, e, in primo luogo, con il dualismo. Il bambino impara a classificare persone e oggetti in due gruppi, uno simile a se stesso, l’altro opposto.
Un’altra tendenza caratteristica della prima infanzia è quella di definire l’Essere con il Fare. Alla domanda: cos’è un uomo o una donna? il bambino risponde elencando ruoli e funzioni, generalmente stereotipati e opposizionali. Per questo la critica della teoria dei ruoli sessuali negli Stati Uniti (Joseph H. Pleck, The Myth of Masculinity), legittima quando riguarda gli uomini e le donne adulti, deve essere meno rigida quando riguarda i bambini. Se è normale insegnare le stesse cose ai bambini dei due sessi, è anche necessario lasciare a ciascuno la possibilità di esprimere la propria differenza e opposizione. Papà e mamma possono essere entrambi impiegati o medici, condividere i lavori di casa e le incombenze familiari, ma il bambino proverà sempre il bisogno di trovare un criterio (anche immaginario) di distinzione tra loro, che l’aiuti a differenziarsi da uno e a identificarsi con l’altro.
L’universale segregazione sessuale dei bambini
In tutte le società umane arriva sempre il momento in cui i bambini maschi e femmine si separano per formare dei gruppi dello stesso sesso. Anche a Tahiti, dove la differenziazione sessuale è una delle meno marcate del mondo, bambini e bambine cessano di giocare insieme verso la pre-adolescenza. Cominciano a separarsi a dieci, dodici anni, e fino a quindici, sedici anni il gruppo dei ragazzi non frequenta più le ragazze. E’ l’età delle amicizie “omosessuali” così importanti per consolidare l’identità sessuale. Nelle società occidentali la separazione dei sessi avviene prima e dura più a lungo.
In un recente articolo (giugno 1990), E. Maccoby, forte delle sue ricerche e della letteratura attuale sull’argomento, può affermare: “Dalla scuola materna alla pubertà, i bambini si raggruppano generalmente per sesso”. Nel loro studio longitudinale, Maccoby e Jacklin (1987) costatano che a quattro anni e mezzo i bambini della scuola materna passano un tempo tre volte maggiore con i coetanei dello stesso sesso del tempo passato con le compagne del sesso opposto. All’età di sei anni e mezzo, questo rapporto è di undici a uno.
La segregazione è ancora più netta nelle situazioni non strutturate dagli adulti. D’altra parte, se questi ultimi insistono troppo nel loro tentativo di avvicinare i due sessi, i bambini oppongono una resistenza. Tra sei e dodici anni, i bambini evitano i gruppi misti. Barry Thorne ha sottolineato l’intensità delle canzonature che i bambini infliggono a quelli tra loro che manifestano un interesse per l’altro sesso. Secondo Maccoby, questa volontà di evitare il sesso opposto non risulterebbe da una pressione degli adulti. Per quanto la scuola si sforzi di aumentare le attività miste, queste non hanno che un effetto provvisorio: i bambini tornano sempre a un modello di segregazione.
La tendenza a preferire dei compagni di gioco dello stesso sesso comincia molto presto. Maccoby riporta uno studio in un grande asilo infantile canadese (1984) su bambini da uno a sei anni. E’ verso i due anni che le bambine cominciano a rivolgersi alle altre bambine, mentre i maschi non cercano attivamente i compagni dello stesso sesso che verso i tre anni. A cinque anni essi superano le femmine nella preferenza per lo stesso sesso. Maccoby e Jaklin hanno notato che il livello di interazione è molto più elevato nelle coppie non miste: i maschi sono più attivi socialmente quando giocano con un altro bambino invece che con una bambina. A partire dai trentatré mesi, il loro stile di gioco è differente e i bambini preferiscono lo stile dei bambini dello stesso sesso. Le femmine non giocano in modo passivo, ma non hanno i comportamenti fisici e brutali dei maschi.
Secondo Maccoby e Jaklin, le basi della segregazione sessuale preesistono all’entrata dei bambini a scuola. Appaiono quando essi sono quasi del tutto capaci di classificare secondo il sesso tanto se stessi che gli altri. Le differenze constatate tra gruppi di bambini e gruppi di bambine si rapporterebbero a tre fattori principali: la socializzazione del bambino secondo il sesso fin dalla nascita (ma essa varia da un genitore all’altro, da una famiglia all’altra); i fattori biologici; infine i fattori cognitivi ancora poco conosciuti: i bambini possono distinguere un bambino da una bambina molto prima di conoscere le differenze genitali (le categorie “maschio” e “femmina” sono delle categorie binarie fondamentali acquisite molto prima delle categorie “maschile” e “femminile”, che sono fluide e relative).
Questo fenomeno osservabile sempre e dovunque dovrebbe consigliare la prudenza ai detrattori del dualismo sessuale. Se è vero che è stato utilizzato dal patriarcato come un’arma temibile contro le donne, è non meno vero che si tratta di un dato elementare della coscienza identitaria del bambino. Negarlo equivarrebbe a correre il rischio della confusione sessuale che non è mai stata favorevole alla pace tra uomini e donne. Riconoscere che si tratta di una tappa necessaria è forse il solo mezzo per il riconoscimento successivo di una comune bisessualità, o, in altri termini, della somiglianza tra i sessi.