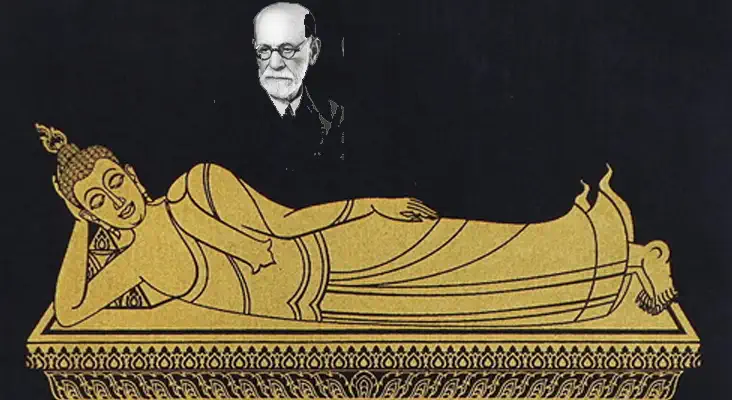Dal Libro: La Saggezza del Dubbio
Messaggio per l’Età dell’Angoscia
di Alan W. Watts (Editore Ubaldini)
Alan W. Watts (1915-1973), inglese di origine trapiantatosi in America nel 1938, è uno dei massimi esperti di teologia e problemi religiosi. E’ conosciuto soprattutto per i suoi studi sulla filosofia e la spiritualità orientali, in particolare, il Buddhismo e il Taoismo. Ha insegnato alle università di Cambridge, Cornell, e delle Hawaii. Molti dei suoi libri sono stati tradotti in italiano, tra gli altri: La suprema identità, Uomo, donna, natura, La gaia cosmologia, Om: meditazioni creative, Psicoterapie orientali e occidentali, Il libro, La via dello zen, Il significato della felicità, Il Tao: la via dell’acqua che scorre.
La grande corrente
Sembriamo mosche invischiate nel miele. Siccome la vita è dolce non la vogliamo abbandonare, ma più vi siamo coinvolti più ci sentiamo intrappolati, limitati, frustrati. La amiamo e la odiamo a un tempo. Ci innamoriamo delle persone e delle proprietà solo per essere torturati dall’ansia per esse. Il conflitto non è soltanto fra noi e l’universo che ci circonda; è anche fra noi e noi. L’indocile natura è infatti sia intorno a noi sia in noi. L’esasperante ‘vita’, che è insieme appassionante ed effimera, piacevole e dolorosa, benedizione e maledizione, è anche la vita del nostro corpo.
E’ come se fossimo divisi in due. Da un lato c’è l’ ‘Io’ cosciente, affascinato e ingannato al tempo stesso, la creatura presa in trappola: Dall’altro c’è il ‘me’, e il ‘me’ appartiene alla natura: la carne ribelle, con tutte le sue limitazioni simultaneamente belle e frustranti. L’ ‘Io’ ha un’alta opinione di sé come persona ragionevole, e critica eternamente il ‘me’ per la sua perversità: perché alimenta le passioni che mettono l’ ‘Io’ nei guai, perché va soggetto a malattie irritanti e dolorose, perché ha organi che si logorano e appetiti che non possono mai essere soddisfatti – progettati in modo tale che, se cerchiamo di acquietarli in maniera definitiva e completa in un solo grande ‘seno’, diventiamo ammalati.
Forse la cosa più esasperante del ‘me’, della natura, dell’universo è la loro continua instabilità: sono come una bella donna che non si fa mai afferrare e il cui fascino sta proprio nella sua incostanza. La caducità e la mutevolezza del mondo sono parti integranti della sua vivacità e bellezza. Perciò tanto spesso i poeti scrivono le loro cose migliori quando parlano di mutamento, di ‘fugacità della vita umana’: La bellezza di una tale poesia sta in qualcosa di più di una nota di nostalgia che dà un nodo alla gola:
I nostri divertimenti sono ora finiti. Questi nostri attori,
Come vi avevo annunciato, erano tutti spiriti, e
Si sono dissolti nell’aria, nell’aria sottile:
E, come l’esile trama di questa visione,
Le torri coperte di nuvole, i sontuosi palazzi,
I templi solenni, lo stesso enorme globo,
Sì, tutto ciò che esso eredita, svanirà,
E, come questo inconsistente sforzo sbiadito,
Non lascerà dietro di sé rovine.
In questa bellezza c’è qualcosa di più che una successione di immagini, e il tema della dissoluzione non deriva la sua magnificenza soltanto dal dissolversi delle cose. E’ vero piuttosto che le immagini, pur belle in se stesse, prendono vita nell’atto di svanire. Il poeta le spoglia della loro statica solidità e trasforma una bellezza che resterebbe altrimenti solo statuaria e architettonica, in una musica che si affievolisce e muore non appena la suoni. Le torri, i palazzi, i templi diventano vibranti e si spezzano per la troppa vita che è in loro. Passare è vivere; rimanere e continuare è morire. “Se il granello di frumento caduto nella terra non muore, rimane solo; ma se invece muore, produce molto frutto”.
I poeti hanno colto questa verità: vita, mutamento, movimento e insicurezza non sono che nomi diversi della stessa cosa. Qui, se non ovunque, la verità è bellezza, perché movimento e ritmo sono l’essenza d’ogni cosa bella. Nella scultura, architettura e pittura, le forme finite sono immobili, e nondimeno l’occhio trova piacere nella forma solo quando essa presenta una certa mancanza di simmetria, quando, seppure irrigidita nella pietra, sembra essere in pieno movimento.
Non è allora una strana incongruenza, un innaturale paradosso che l’ ‘Io’ si opponga al mutamento nel ‘me’ e nell’universo circostante? Il mutamento, infatti, non è pura forza di distruzione. Ogni forma è in realtà un modello di movimento, e ogni essere vivente è come il fiume che se non defluisse non potrebbe mai fluire. Vita e morte non sono due forze opposte; sono semplicemente due diversi modi di considerare la stessa forza, perché il moto del mutamento è il costruttore nella stessa misura in cui è il distruttore. Il corpo umano vive perché è un complesso di movimenti, di circolazione, respirazione e digestione. Opporsi al mutamento, cercare di aggrapparsi alla vita è come trattenere il respiro: persistendo ci si uccide.
Quando immaginiamo di essere divisi in un ‘Io’ e un ‘me’, dimentichiamo facilmente che anche la coscienza vive in quanto si muove. E’ parte e prodotto della corrente del mutamento alla stessa stregua del corpo e di tutto il mondo naturale. Se la esaminiamo attentamente, vediamo che la coscienza – la cosa che chiamiamo l’ ‘Io’ – è in realtà una coscienza di esperienze, di sensazioni, pensieri e sentimenti in costante movimento. Ma poiché queste esperienze comprendono i ricordi, abbiamo l’impressione che l’ ‘Io’ sia qualcosa di solido e stabile, come una tavola sulla quale la vita scrive una testimonianza.
Invece la ‘tavola’ si muove con il dito che scrive, come il fiume scorre con le sue increspature, sicché il ricordo è come una testimonianza scritta sull’acqua – testimonianza non di lettere incise, ma di onde messe in moto da altre onde che vengono chiamate sensazioni e fatti. La differenza tra l’‘Io’ e il ‘me’ è in gran parte un’illusione della memoria. In realtà l’ ‘Io’ ha la stessa natura del ‘me’. E’ parte del nostro intero essere come la testa è parte del corpo. Ma se non ce ne rendiamo conto, ci sembrerà che l’ ‘Io’ e il ‘me’, la testa e il corpo siano in disaccordo. Non comprendendo di appartenere anch’esso alla corrente del mutamento, l’ ‘Io’ cercherà di dare un senso al mondo e all’esperienza cercando di fissarla.
Avremo allora guerra tra coscienza e natura, tra il desiderio della permanenza e la realtà del flusso. Una guerra amaramente vana e frustrante – un circolo vizioso – perché è un conflitto tra due parti della stessa cosa. Essa guida inevitabilmente il pensiero e l’azione in un moto circolare sempre più rapido che non porta in alcun luogo. Se infatti non riusciamo a vedere che la nostra vita è mutamento, ci poniamo contro noi stessi e diventiamo come Ouroboros, il serpente indotto in errore che cerca di mangiarsi la coda. Ouroboros è il simbolo perenne di ogni circolo vizioso, di ogni tentativo di spaccare il nostro essere e di far sì che una parte soggioghi l’altra.
Per quanti sforzi possiamo fare, il ‘fissare’ non ci farà mai capire il significato del mutamento. Il solo modo di capire il significato del mutamento è tuffarsi in esso, muoverci con esso, partecipare alla danza.
La religione, come l’ha conosciuta la maggior parte di noi, ha cercato nel modo più evidente di capire il significato della vita come fissazione. Ha cercato di dare un significato a questo mondo transeunte riferendolo a un Dio immutabile e vedendone l’obiettivo e lo scopo in una vita immortale in cui l’individuo diventa tutt’uno con l’invariabile natura della divinità. “L’eterno riposo dà loro, o Signore, e fa che su di essi splenda la luce perpetua”. Allo stesso modo essa tenta di dare un senso ai vorticosi movimenti della storia riferendoli alle stabili leggi di Dio, “il cui Mondo non avrà mai fine”.
Ci siamo così creati un problema confondendo l’intelligibile con lo stabile. Pensiamo che sia impossibile trovare il significato della vita a meno che non si riesca in qualche modo a immettere il flusso degli eventi in una struttura di forme rigide. Per avere un senso, la vita dev’essere comprensibile in termini di idee e leggi stabili, e a loro volto queste devono corrispondere a realtà immutabili ed eterne che stanno dietro la scena che cambia. (Nel prosieguo di quest’opera vedremo come queste idee metafisiche dell’immutabile e dell’eterno possano avere un senso diverso. Esse non implicano necessariamente una visione statica della realtà, e seppure si usino di solito come tentativi di ‘fissare il flusso’, non sono sempre state tali.) Ma se è questo che si intende per “trovare il senso della vita”, ci siamo assunti l’impossibile compito di trarre la stabilità dal fluire.
Prima di cercare se non vi sia un modo migliore per capire il nostro universo, dobbiamo vedere chiaramente come sia avvenuta questa confusione tra ‘senso’ e ‘stabilità’. Alla radice della difficoltà sta il fatto che abbiamo sviluppato la capacità di pensare in modo così rapido e unilaterale da scordare il giusto rapporto fra pensieri ed eventi, parole e cose. Il pensiero cosciente ha progredito molto e si è creato un proprio mondo; quando constatiamo che questo è in conflitto con il mondo della realtà, abbiamo l’impressione che vi sia un profondo disaccordo tra l’ ‘Io’, il pensatore cosciente, e la natura. Questo sviluppo unilaterale dell’uomo non è peculiare degli intellettuali e dei ‘cervelloni’, che sono solo gli esempi estremi di una tendenza che riguarda tutta la nostra civiltà.
Abbiamo scordato che pensieri e parole sono convenzioni, e che è funesto prendere troppo sul serio le convenzioni. La convenzione è una comodità sociale, per esempio il denaro. Il denaro libera dal disturbo del baratto. Ma è assurdo prendere troppo sul serio il denaro, confonderlo con un bene reale, perché non possiamo certo mangiarlo né usarlo come indumento. Il denaro è più o meno statico, perché l’oro, l’argento, le banconote o un conto in banca possono rimanere stabili a lungo. Ma un bene reale, come il cibo, è deperibile. Una comunità può possedere tutto l’oro del mondo, ma se non coltiva le sue messi muore di fame.
Pressappoco allo stesso modo pensieri, idee e parole sono ‘monete’ per le cose reali. Non sono queste cose e, anche se le rappresentano sotto molti aspetti non vi corrispondono affatto. Tra pensieri e cose c’è lo stesso rapporto che tra denaro e beni: le idee e le parole sono più o meno stabili, mentre le cose reali cambiano.
E’ più facile dire ‘Io’ che richiamare l’attenzione sul proprio corpo; dire ‘fame’ che cercare di indicare la vaga sensazione nella bocca e nello stomaco. E più comodo dire ‘acqua’ che portare l’amico al pozzo e compiere i gesti del caso. E’ anche comodo convenire di usare le stesse parole per le stesse cose, e lasciare queste parole immutate anche se le cose che esse indicano sono in costante movimento.
Da principio il potere delle parole dev’essere sembrato magico: impressione pianamente giustificata dai miracoli compiuti dal pensiero verbale. Che meraviglia dev’essere stata la possibilità di sbarazzarsi del linguaggio dei segni e di chiamare un amico emettendo un breve suono: il suo nome! Non stupisce che i nomi siano stati considerati manifestazioni misteriose di un potere sovrannaturale, e che gli uomini abbiamo identificato il loro nome con la loro anima o se ne siano serviti per invocare delle forze spirituali. In effetti, il potere delle parole ha dato alla testa all’uomo in vari modi. Definire è giunto a significare quasi la stessa cosa che capire. Anche più importante è il fatto che le parole abbiano reso l’uomo capace di definirsi, di etichettare come ‘Io’ una certa parte della sua esperienza.
E’ questo, forse, il significato dell’antica credenza che il nome sia l’anima. In effetti, definire è isolare, è separare un complesso di forme dalla corrente della vita e dire: “Questo sono io”. quando l’uomo riesce a darsi un nome e a definirsi si accorge di avere un’identità. Allora comincia a sentirsi, come la parola, separato e statico, in netta contrapposizione al reale e fluido mondo della natura.
Con il senso di separatezza nasce anche la sensazione di un conflitto fra l’uomo da un lato e la natura dall’altro. Linguaggio e pensiero vengono alle prese con questo conflitto e si applica ora all’universo intero quel potere magico che permette di chiamare un uomo nominandolo. Le forze dell’universo ricevono un nome, sono personalizzate e invocate nella mitologia e nella religione. I processi naturali sono resi intelligibili, perché tutti i processi regolari – come la rotazione delle stelle e delle stagioni – possono essere messi in parole e attribuiti all’attività degli dei o di Dio, il Mondo eterno. In un secondo tempo la scienza impiegherà lo stesso procedimento: studierà ogni tipo di regolarità nell’universo, stabilirà nomi e classificazioni e se ne servirà in modo anche più miracoloso.
Ma poiché è proprio dell’uso e della natura delle parole e dei pensieri il fatto di essere fissati, definiti, isolati, è estremamente arduo descrivere la più importante caratteristica della vita: il suo movimento e la sua fluidità. Così come il denaro non rappresenta la deperibilità e la commestibilità del cibo, così le parole e i pensieri non rappresentano la vitalità della vita. Il rapporto fra pensiero e movimento è qualcosa di simile alla differenza che passa tra un uomo reale che corra e una pellicola cinematografica che mostri la corsa come una serie di fotogrammi.
Ricorriamo alle convenzioni dei fotogrammi ogni qual volta vogliamo descrivere o pensare un corpo in movimento, per esempio, un treno, specificando che in quei dati momenti esso si trova in quei dati luoghi. Ma in realtà le cose non stanno così. Possiamo dire che un treno si trova in un particolare punto ‘adesso’. Ma ci occorre un certo tempo per dire ‘adesso’, e durante questo tempo, anche se breve, il treno ha continuato a muoversi. Possiamo dire che il treno in movimento è (ossia sta fermo) in un particolare punto per un particolare istante, ma solo se entrambi sono infinitamente piccoli. Ma i punti infinitamente piccoli e gli istanti fissi sono sempre immaginari, appartengono alla teoria matematica piuttosto che al mondo della realtà.
Per il calcolo scientifico la cosa più comoda è concepire il movimento come una serie di piccolissimi scatti o fotogrammi. Ma sorge una confusione quando il mondo descritto e misurato con queste convenzioni viene identificato con il mondo dell’esperienza. Una serie di fotogrammi, a meno che non venga mossa rapidamente davanti ai nostri occhi, non ci dà l’essenziale vitalità e bellezza del movimento. La definizione, la descrizione tralascia la cosa più importante.
Per quanto queste convenzioni siano utili ai fini del calcolo, del linguaggio e della logica, sorgono delle assurdità se pensiamo che il tipo di linguaggio che usiamo, o il tipo di logica con cui ragioniamo, possano effettivamente definire o spiegare il mondo ‘fisico’. La frustrazione dell’uomo è in parte dovuta al fatto che egli si è abituato ad attendersi che il linguaggio e il pensiero gli offrano spiegazioni che non possono dare. Volere che la vita sia ‘intelligibile’ in questo senso significa volere che essa sia qualcosa di diverso dalla vita. Significa preferire il film all’uomo reale che sta correndo. Considerare la vita senza significato se l’ ‘Io’ non può essere permanente è come essersi innamorati disperatamente di un millimetro.
Parole e misure non danno la vita: si limitano a simboleggiarla. Perciò tutte le ‘spiegazioni’ dell’universo espresse col linguaggio sono circolari, e lasciano inspiegato e indefinito l’essenziale. Lo stesso dizionario è circolare, perché definisce le parole in termini di altre parole. Il dizionario si avvicina un po’ di più alla vita quando di certo vocaboli ci dà anche l’immagine illustrata. Ma si noterà che tutte le illustrazioni dei dizionari riguardano sostantivi anziché verbi. L’illustrazione del verbo correre dovrebbe essere una serie di fotogrammi, come nei fumetti, poiché le parole e le immagini statiche non possono né definire né spiegare il movimento.
Anche i sostantivi sono convenzioni, Non definiamo questo ‘qualcosa’ di reale, di vivo associandovi il suono uomo. Quando diciamo: “Questo (indicandolo con il dito) è un uomo”, la cosa che indichiamo non è l’uomo. Per essere più chiari avremmo dovuto dire: “Questo è simboleggiato dal suono uomo”. Ma allora cos’è questo? Non lo sappiamo. Ossia, non lo possiamo definire in alcun modo stabile, anche se in un altro senso lo conosciamo come nostra esperienza diretta – un processo che fluisce senza principio o fine definibili. Solo la convenzione mi persuade che sono semplicemente questo corpo, legato allo spazio dell’epidermide, e al tempo dalla nascita e dalla morte.
Dove comincio e dove finisco nello spazio? Ho rapporti con il sole e l’aria che per la mia esistenza sono parti altrettanto vitali che il mio cuore. Il movimento di cui sono un elemento o una spira ha avuto inizio in un’epoca infinitamente anteriore all’evento (isolato convenzionalmente) chiamato nascita, e continuerà a lungo dopo l’evento chiamato morte. Solo le parole e le convenzioni ci possono isolare da quel qualcosa di assolutamente indefinibile che è il tutto.
Orbene, queste sono parole utili sino a quando le trattiamo come convenzioni e le usiamo come le linee immaginarie della latitudine e della longitudine tracciate sulle carte geografiche, ma che non troviamo certo sulla faccia della terra. In pratica però siamo tutti stregati dalle parole. Le confondiamo con il mondo reale e cerchiamo di vivere nel mondo reale come se fosse il mondo delle parole. Di conseguenza restiamo sorpresi e sgomenti quando esse sono inadeguate. Più cerchiamo di vivere nel mondo delle parole e più ci sentiamo isolati e soli, e rinunciamo alla gioia e alla vitalità delle cose in cambio della pura certezza e sicurezza. D’altra parte, più siamo costretti a riconoscere che viviamo effettivamente nel mondo reale più ci sentiamo ignoranti, incerti, insicuri verso ogni cosa.
Ma non può esservi salute mentale sino a quando non si scorga la differenza tra i due mondi. La portata e la finalità della scienza sono disgraziatamente travisate se l’universo che essa descrive viene confuso con l’universo in cui vive l’uomo. La scienza parla di un simbolo dell’universo reale, e questo simbolo ha pressappoco la stessa utilità del denaro. E’ un comodo accorgimento che nelle disposizioni pratiche consente un risparmio di tempo. Ma se si confondono denaro e sostanze, realtà e scienza, il simbolo diventa uno svantaggio.
Allo stesso modo l’universo descritto nella religione formale, dogmatica non è che un simbolo del mondo reale, essendo formato anch’esso di distinzioni verbali e convenzionali. Separare ‘questa persona’ dal resto dell’universo è fare una separazione convenzionale. Volere che ‘questa persona’ sia eterna è volere che le parole siano la realtà e sostenere che una convenzione dura per sempre. Agogniamo alla perpetuità di qualcosa che non è mai esistito. La scienza ha ‘distrutto’ il simbolo religioso del mondo perché, quando si confondono i simboli con la realtà, i vari modi di simboleggiare la realtà sembreranno contraddittori.
La maniera scientifica di simboleggiare il mondo si attaglia meglio alle finalità utilitarie che alla vita religiosa, ma ciò non significa che contenga più ‘verità’. E’ più vero classificare i conigli secondo il tipo di alimentazione o secondo il pelo? Dipende da ciò che se ne vuol fare. Il contrasto tra scienza e religione non ha mostrato che la religione è falsa e la scienza è vera. Ha mostrato che tutti i sistemi di definizione sono relativi a vari scopi, e che di fatto nessuno di essi ‘coglie’ la realtà. E poiché si stava facendo cattivo uso della religione come mezzo per cogliere e possedere effettivamente il mistero della vita, era assolutamente necessario un certo ‘ridimensionamento’.
Ma sembra che cercando di simboleggiare l’universo in questo o in quel modo, per questo o quello scopo, noi abbiamo perso la vera gioia e il vero significato della vita stessa. Le varie definizioni dell’universo hanno tutte un motivo recondito: riguardano più il futuro che il presente. La religione vuole assicurare il futuro oltre la morte, mentre la scienza vuole assicurarlo fino alla morte, e rimandare la morte. Ma il domani e i progetti per il domani possono restare senza alcuna importanza se non siamo in pieno contatto con la realtà del presente, perché è nel presente e solo nel presente che viviamo. Non c’è altra realtà che la realtà presente, per cui, se anche dovessimo vivere per un tempo senza fine, vivere per il futuro significherebbe continuare eternamente a non capire la vita.
Ma è proprio questa realtà del presente, questo adesso in movimento, vitale, a eludere ogni definizione e descrizione. Ecco il misterioso mondo reale che le parole e le idee non possono mai immobilizzare. Vivendo sempre nel futuro non siamo in contatto con questa sorgente e centro di vita, con il risultato che ogni magia del denominare e del pensare è quasi giunta al collasso.
I miracoli della tecnologia ci fanno vivere in un mondo febbrile, meccanico, che fa violenza alla biologia umana, rendendoci atti a non far altro che inseguire sempre più in fretta il futuro. Il pensiero calcolato si sente incapace di controllore l’insorgere della bestia nell’uomo – una bestia più ‘bestiale’ di ogni creatura del mondo selvaggio, resa furibonda ed esasperata dal perseguimento delle illusioni. La specializzazione del frasario, della classificazione, del pensiero automatizzato ha fatto perdere all’uomo il contatto con molte delle meravigliose facoltà dell’istinto che governano il suo corpo. Gli ha anche dato l’impressione d’essere completamente separato dall’universo e dal suo stesso ‘me’. Così, mentre ogni filosofia si è dissolta nel relativismo e non riesce più a dare un senso stabile all’universo, l’ ‘Io’ isolato si sente miseramente insicuro e impaurito, accorgendosi che il mondo reale è in netta contraddizione con tutto il proprio essere.
Certo, non c’è niente di nuovo in questa triste situazione della scoperta che le idee e le parole non possono aderire ai misteri ultimi della vita, che la Realtà o, se si preferisce, Dio, non può essere compresa dalla mente finita. L’unica novità è che ora questa situazione è sociale anziché individuale, è avvertita da molti, non limitata a pochi. Quasi tutte le tradizioni spirituali riconoscono che a un certo punto devono accadere due cose: l’uomo deve rinunciare al proprio ‘Io’ separatamente-senziente e affrontare il fatto che non può conoscere, ossia definire il fondamento supremo.
Queste tradizioni riconoscono anche che al di là di questo punto c’è una ‘visione di Dio’ che non può essere espressa a parole e che certo è assai diversa dal fatto di percepire un signore splendente in un trono d’oro o un vero e proprio lampo di luce abbagliante. Indicano anche che questa visione è il ripristino di qualcosa che avevamo e che abbiamo ‘perso’ perché non lo apprezzavamo o non sapevamo apprezzarlo. Questa visione è dunque la limpida consapevolezza di questo indefinibile ‘qualcosa’ che chiamiamo vita, realtà presente, la grande corrente, l’eterno ora – una consapevolezza senza il sentimento di esserne separati.
Nel momento in cui lo nomino esso non è più Dio; è uomo, albero, verde, nero, rosso, molle, duro, lungo, corto, atomo, universo. Saremmo senz’altro d’accordo con ogni teologo il quale deplori il panteismo sul fatto che questi elementi che appartengono al mondo del lessico e della convenzione, queste svariate ‘cose’ concepite come entità stabili e distinte, non sono Dio. Se mi chiedi di mostrarti Dio, ti indicherò il sole, o un albero o un verme. Ma se dici “Intendi dire, allora, che Dio è il sole, l’albero, il verme e tutte le altre cose?”, dovrò risponderti che sei completamente fuori strada.
Essere consapevoli
La domanda: “Cosa dobbiamo fare in proposito?”, è posta solo da chi non capisce il problema: Se un problema può essere risolto, capirlo e sapere che cosa fare in proposito sono la stessa cosa. Per contro, fare qualcosa circa un problema che non si capisce è come cercare di spazzare via l’oscurità allontanandola con le mani. Quando facciamo luce l’oscurità svanisce di colpo.
Ciò vale in particolare per il problema che ora ci sta di fronte. Come sanare la frattura tra l’ ‘Io’ e il ‘me’, la mente e il corpo, l’uomo e la natura, e far cessare tutti i circoli viziosi che essa determina? In che modo sperimentare la vita come qualcosa di diverso dalla trappola di miele nella quale ci dibattiamo come mosche? Come trovare sicurezza e tranquillità di mente in un mondo la cui vera natura è l’insicurezza, l’impermanenza, il mutamento incessante? Tutte queste domande esigono un metodo e una linea d’azione. Al tempo stesso ci dimostrano che il problema non è stato capito. Non abbiamo bisogno dell’azione – non ancora. Abbiamo bisogno di più luce.
Luce qui significa consapevolezza: essere consapevoli della vita, dell’esperienza così com’è in questo momento, senza alcun giudizio o idea su di essa. In altre parole, dobbiamo vedere e sentire ciò che stiamo sperimentando così com’è, non come lo si definisce. Questo semplicissimo ‘aprire gli occhi’ provoca la più straordinaria trasformazione della comprensione e della vita, e ci mostra come molti dei nostri problemi più sconcertanti siano pure illusioni. Questa può sembrare un’eccessiva semplificazione perché la maggior parte della gente pensa di avere già una consapevolezza abbastanza piena del presente, ma vedremo che le cose non stanno affatto così. (Uso il termine ‘consapevolezza’ come lo intende J. Krishnamurti, i cui scritti discutono questo tema con straordinaria intelligenza.)
Siccome la consapevolezza è una visione della realtà libera da idee e giudizi, è chiaramente impossibile definire e mettere per iscritto che cosa essa riveli. Tutto ciò che può essere descritto è un’idea e non posso affermare nulla di certo in merito a qualcosa – il mondo reale – che non è un’idea. Devo quindi limitarmi a parlare delle false impressioni che la consapevolezza rimuove piuttosto che della verità che essa rivela. Quest’ultima può essere soltanto simboleggiata con parole che significano poco o nulla per quanti non abbiano una comprensione diretta della verità in questione.
Ciò che è vero e certo è troppo reale e troppo vivo per essere descritto: cercare di farlo è come pitturare di rosso una rosa rossa. Perciò quanto segue avrà necessariamente, per la maggior parte, una qualità piuttosto negativa. La verità è rivelata rimuovendo ciò che fa ombra: arte non dissimile dalla scultura, in cui l’artista crea non costruendo ma togliendo a colpi di scalpello.
Abbiamo visto come le domande sul perseguimento della sicurezza e della pace in un mondo impermanente dimostrino che il problema non è stato capito. Prima di procedere oltre dev’essere chiaro che la sicurezza di cui stiamo parlando è in primo luogo spirituale e psicologica. Per esistere gli esseri umani devono avere un minimo di mezzi di sussistenza in termini di cibo, bevande e vestiario – nell’intesa, tuttavia, che tali mezzi non possono durare indefinitamente. Ma se la certezza di avere questo minimo vitale per una sessantina d’anni cominciasse a soddisfare il cuore dell’uomo, i problemi umani sarebbero ben poca cosa. In realtà, il vero motivo per cui questa certezza ci manca è il fatto che vogliamo assai più del minimo necessario.
Dev’essere chiaro fin dall’inizio che c’è una contraddizione nel voler essere perfettamente sicuri in un universo la cui vera natura è transitorietà e fluidità. Ma è una contraddizione leggermente più profonda che il semplice conflitto tra il desiderio di sicurezza e il fatto del mutamento. Se voglio essere sicuro, cioè protetto contro il fluire della vita, voglio essere separato dalla vita. Eppure è proprio questo senso di separazione che mi fa sentire insicuro. Essere sicuro significa isolare e rafforzare l’ ‘Io’, ma è proprio l’impressione di essere un ‘Io’ isolato a farmi sentire solo e impaurito. In altre parole, più sicurezza potrò avere più ne vorrò.
Più semplicemente: il desiderio di sicurezza e il senso di insicurezza sono la stessa cosa. Trattenere il respiro è perderlo. Una società che si fondi sul perseguimento della sicurezza non è altro che una gara a chi trattiene più il fiato, in cui ognuno è teso come un tamburo e paonazzo come una barbabietola.
Perseguiamo questa sicurezza rafforzandoci e racchiudendoci in noi in moltissimi modi. Vogliamo la protezione che ci viene dall’essere ‘esclusivi’ e ‘speciali’, cercando di appartenere alla chiesa più sicura, alla nazione migliore, alla classe più alta, all’ambiente giusto, alla gente ‘per bene’. Queste difese provocano tra noi delle divisioni, e quindi più insicurezza che esige più difese. Naturalmente facciamo tutto nella sincera convinzione di essere nel giusto e di vivere nel modo migliore; ma anche questo è una contraddizione.
Posso solo fare qualche serio tentativo di vivere secondo un ideale, di migliorarmi, se sono scisso in due. Ci dev’essere un ‘Io’ buono che cerca di rendere migliore il ‘me’ cattivo. L’ ‘Io’ che ha le migliori intenzioni cercherà di lavorarsi l’indocile ‘me’ e il contrasto tra i due ne metterà in rilievo il divario. Di conseguenza l’ ‘Io’ si sentirà più separato che mai, e non farà che acuire i sentimenti di solitudine e isolamento che determinano il cattivo comportamento del ‘me’.
Difficilmente riusciamo a prendere in considerazione questo problema se non ci è chiaro che la brama di sicurezza è essa stessa dolore e contraddizione, e che più la perseguiamo più diventa dolorosa. Ed è così per qualsiasi forma di sicurezza si possa concepire.
Vuoi essere felice, dimentico di te stesso, ma più cerchi di dimenticarti più ricordi il sé che vuoi dimenticare. Vuoi sottrarti al dolore, ma più lotti per farlo più attizzi il tormento. Hai paura e vuoi essere coraggioso, ma lo sforzo per essere coraggioso è solo paura che tenta di sfuggire a se stessa. Vuoi la tranquillità dello spirito, ma il tentativo di tranquillizzarlo è come cercare di sedare le onde con un ferro da stiro.
Tutti abbiamo dimestichezza con questa specie di circolo vizioso sotto forma di inquietudine. Sappiamo che essere inquieti non serve a niente, ma continuiamo a inquietarci perché dire che non serve a niente non fa cessare l’inquietudine. Siamo inquieti perché ci sentiamo in pericolo e vogliamo essere al sicuro. Ma è perfettamente inutile dire che non dovremmo voler essere al sicuro. Ingiuriando un desiderio non ce ne liberiamo. Quel che dobbiamo scoprire è che non c’è alcuna sicurezza, che cercarla è doloroso e che, quando pensiamo di averla trovata, non ci piace. In altre parole, se riusciremo veramente a capire ciò che stiamo cercando – che la sicurezza è isolamento, e che cosa facciamo a noi stessi quando la cerchiamo – ci accorgeremo di non volerla affatto. Non occorre che ci vengano a dire che non dovremmo trattenere il respiro per dieci minuti. Sappiamo benissimo che non possiamo farlo e che tentare di farlo è quanto mai scomodo.
La prima cosa da capire è che non c’è scampo né sicurezza. Uno dei peggiori circoli viziosi è il problema dell’alcolista. In moltissimi casi egli sa benissimo che si sta distruggendo, che per lui il liquore è veleno, che odia davvero essere ubriaco e addirittura non può soffrire il gusto del liquore. Eppure beve. Perché, per quanto possa detestare il bere, l’esperienza del non bere è peggiore. Gli provoca le ‘allucinazioni’ perché lo mette di fronte alla fondamentale, non più velata, insicurezza del mondo.
Qui sta il punto cruciale della questione. Essere posto di fronte all’insicurezza equivale ancora a non capirla. Per capirla non la si deve fronteggiare, si deve essere l’insicurezza. E’ come la storia persiana del saggio che giunse alla porta del Cielo e bussò. Dall’interno la voce di Dio chiese: “Chi è là?”. Il saggio rispose: “Sono io”. “In questa casa”, replicò la voce, “non c’è posto per te e me”. Il saggio venne via e passò molti anni a riflettere su questa risposta in profonda meditazione. Tornò poi una seconda volta, la voce gli fece la stessa domanda e il saggio rispose di nuovo: “Sono io”. La porta rimase chiusa: Dopo qualche anno tornò per la terza volta e quando bussò la voce gli chiese ancora: “Chi è là?”. Allora il saggio gridò: “Sei tu!”, e la porta gli fu aperta.
Capire che non c’è sicurezza è assai più che essere d’accordo sulla teoria che ogni cosa cambia, assai più, anche, che osservare la transitorietà della vita: la nozione di sicurezza si fonda sul sentimento che in noi ci sia qualcosa di permanente, qualcosa che dura attraverso tutti i giorni e i cambiamenti della vita. Lottiamo per essere sicuri della permanenza, continuità e sicurezza di questo nucleo che persiste, di questo centro e anima del nostro essere che chiamiamo ‘Io’. Pensiamo infatti che sia esso l’uomo reale: il pensatore dei nostri pensieri, il senziente dei nostri sentimenti, il conoscitore della nostra conoscenza. Non capiamo proprio che non vi sarà alcuna sicurezza finché non ci renderemo conto che questo ‘Io’ non esiste.
La comprensione giunge attraverso la consapevolezza. Possiamo allora accostarci alla nostra esperienza – sensazioni, sentimenti, pensieri – nel modo più semplice, come se prima li avessimo sempre ignorati, ed esaminare senza preconcetti ciò che sta accadendo? Mi si potrà chiedere: “Quali esperienze, sensazioni, sentimenti dobbiamo esaminare?” replicherò: “Quali sono quelli che si possono esaminare?”. La risposta è che vanno presi in esame quelli che si hanno ora.
Certo, è piuttosto ovvio: Ma spesso trascuriamo proprio le cose più ovvie. Se un sentimento non è presente, non ne siamo coscienti. Non c’è altra esperienza che l’esperienza presente. Ciò che sappiamo, ciò di cui siamo effettivamente consapevoli, è solo ciò che sta accadendo in questo momento, nient’altro.
Ma i ricordi, allora? Certo, ricordando posso anche conoscere ciò che è passato. Benissimo, ricorda qualcosa. Ricorda l’episodio dell’incontro di un amico per strada. Di che cosa sei consapevole? Non stai effettivamente assistendo al vero avvenimento dell’incontro col tuo amico. Non puoi andare a stringergli la mano o avere la risposta a una domanda che ti eri dimenticato di fargli nel momento passato che stai ricordando. In altre parole, non stai affatto esaminando il vero passato. Stai esaminando la traccia presente del passato.
E’ come vedere le orme di un uccello sulla sabbia. Vedo le orme che ci sono adesso. Non vedo contemporaneamente l’uccello che un’ora fa le ha lasciate. L’uccello è volato via e non lo vedo. Deduco dalle impronte che è stato qui. Dai ricordi deduciamo che vi sono stati degli avvenimenti passati. Ma non abbiamo la consapevolezza immediata di alcun avvenimento passato. Conosciamo il passato solo nel presente e come parte del presente.
Abbiamo visto dunque che la nostra esperienza è assolutamente momentanea. Da un punto di vista ogni istante è così elusivo e breve che non riusciamo neppure a pensarlo prima che sia scomparso. Ma da un altro punto di vista quest’istante è sempre qui, perché non conosciamo altro istante che quello presente. Esso continua a morire, a diventare passato più velocemente di quanto l’immaginazione possa concepire. Ma al tempo stesso continua a nascere, sempre nuovo, emergendo con altrettanta velocità da quell’assoluto ignoto che chiamiamo il futuro. Pensarlo è qualcosa che lascia quasi senza fiato.
Dire che l’esperienza è momentanea equivale in realtà a dire che l’esperienza e l’istante presente sono la stessa cosa. Dire che quest’istante continua a morire, o a diventare passato, e che continua nascere, o a venire fuori dall’ignoto, equivale a dire la stessa cosa dell’esperienza. L’esperienza che si è appena avuta è svanita ed è irrecuperabile; tutto ciò che ne rimane non è altro che una specie di scia o impronta nel presente che chiamiamo ricordo. Se possiamo avanzare qualche congettura sulla prossima esperienza che avremo, in realtà non ne sappiamo niente. Potrebbe accadere qualsiasi cosa. Ma l’esperienza in corso ora è, per così dire, un neonato che svanisce ancor prima di cominciare a crescere.
Mentre seguiamo questa esperienza presente, siamo consapevoli che qualcuno la sta seguendo? Possiamo trovare, oltre all’esperienza in se stessa, uno sperimentatore? Possiamo, contemporaneamente, leggere questa frase e pensare noi stessi in atto di leggerla? Constateremo che, per farlo, dobbiamo smettere di leggere per un istante. La prima esperienza è la lettura: la seconda esperienza è il pensiero: “Sto leggendo”. Possiamo trovare un lettore, il quale stia pensando il pensiero: “Sto leggendo”? In altre parole, quando l’esperienza presente è il pensiero: “Sto leggendo”, è possibile pensare noi stessi in atto di pensare questo pensiero?
Dobbiamo di nuovo smettere di pensare velocemente: “Sto leggendo”, per passare a una terza esperienza, al pensiero: “Sto pensando di stare leggendo”. La rapidità con cui questi pensieri possono cambiare non deve darci l’impressione errata che li pensiamo subito tutti.
Che cosa è avvenuto? Non riuscivamo mai a separarci dal nostro pensiero presente né dalla nostra esperienza presente. La prima esperienza presente era un’esperienza di lettura. Quando cercavamo di pensare noi stessi in atto di leggere, l’esperienza cambiava e l’esperienza presente successiva era il pensiero: “Sto leggendo”. Non riuscivamo a separarci da quest’esperienza senza passare a un’altra. Era un ‘girotondo’. Quando pensavamo: “Sto leggendo questa frase”, non la leggevamo. In altre parole, in ogni esperienza presente eravamo consapevoli soltanto di quella stessa esperienza. Non eravamo consapevoli d’essere consapevoli. Non riuscivamo mai a separare il pensatore dal pensiero, il conoscitore dal conosciuto. Non trovavamo mai nient’altro che un nuovo pensiero, una nuova esperienza.
Essere consapevoli, dunque è essere consapevoli di pensieri, sentimenti, sensazioni, desideri e di ogni altra forma di esperienza: Non c’è mai un momento in cui siamo consapevoli di qualcosa che non sia esperienza, che non sia un pensiero o un sentimento, ma che sia invece uno sperimentatore, pensatore o senziente. Se è così che cosa ci fa pensare che esista una cosa del genere?
Potremmo dire, per esempio, che l’ ‘Io’ pensante è questo corpo fisico e questa mente. Ma questo corpo non è in alcun modo separato dai suoi pensieri e dalle sue sensazioni. Quando abbiamo una sensazione, per esempio una sensazione tattile, essa è parte del nostro corpo. Quando è in atto non possiamo distoglierne il corpo, non più di quanto possiamo allontanarci dal mal di testa o dai nostri piedi. Sinché è presente, questa sensazione è il nostro corpo, siamo noi. Possiamo togliere il corpo da una sedia scomoda, non possiamo distoglierlo dalla sensazione della sedia.
La nozione di un pensatore separato, di un ‘Io’ distinto dall’esperienza, è data dalla memoria e dalla rapidità con cui il pensiero cambia. E’ come fa ruotare rapidamente un bastoncino che brucia per dare l’illusione di un cerchio continuo di fuoco. Se immaginiamo che la memoria sia conoscenza diretta del passato anziché esperienza presente, abbiamo l’illusione di conoscere passato e presente contemporaneamente. Questo ci fa pensare che in noi ci sia qualcosa di distinto sia dalle esperienze passate che dalle esperienze presenti. Ragioniamo così: “Conosco quest’esperienza presente e so che è diversa da quell’esperienza passata. Se posso confrontarle e osservare che l’esperienza è cambiata, ci dev’essere qualcosa di costante e separato”.
Di fatto, però, non possiamo confrontare quest’esperienza presente con un’esperienza passata. Possiamo solo confrontarla con un ricordo del passato, che è parte dell’esperienza presente. Quando vedremo chiaramente che il ricordo è una forma di esperienza presente, diverrà evidente che è impossibile cercare di separarci da quest’esperienza, proprio com’è impossibile cercare di far sì che i denti mordano se stessi. C’è semplicemente l’esperienza. Non c’è qualcosa o qualcuno che sperimenti l’esperienza! Non sentiamo sentimenti, né pensiamo pensieri, né percepiamo percezioni più di quanto non udiamo l’udito, vediamo la vista, odoriamo l’odorato. “Mi sento bene”, significa che è presente una sensazione di benessere. Non significa che c’è una cosa chiamata ‘Io’ e un’altra cosa separata chiamata sensazione, per cui, se le mettiamo insieme, questo ‘Io’ sente il senso di benessere. Non vi sono altre sensazioni che le sensazioni presenti, e qualsiasi sensazione presente è l ‘Io’. Nessuno ha mai trovato un ‘Io’ separato da qualche esperienza presente, o qualche esperienza separata da un ‘Io’ – il che significa semplicemente che ‘Io’ ed esperienza sono la stessa cosa.
Come pura argomentazione filosofica questa è una perdita di tempo. Non stiamo cercando di fare una ‘discussione intellettuale’. Stiamo prendendo coscienza che ogni ‘Io’ separato che pensi i pensieri e sperimenti le esperienze è un’illusione. Capirlo è capire che la vita è assolutamente momentanea, che non c’è permanenza né sicurezza, che non c’è alcun ‘Io’ che possa essere protetto.
C’è una storia cinese su un uomo che si recò da un saggio e gli disse: “Il mio spirito non ha pace. Ti prego di placarmelo”. Il saggio rispose: “Tira fuori il tuo spirito (il tuo ‘Io’) e mettimelo davanti; lo tranquillizzerò”. “Lo vado cercando da molti anni”, replicò l’uomo, “ma non riesco a trovarlo”. “Ecco dunque”, concluse il saggio, “che si è placato!”.
Il vero motivo per cui la vita umana può essere così totalmente esasperante e frustrante non è l’esistenza di fatti chiamati morte, dolore, paura o fame. La cosa pazzesca è che, quando questi fatti sono presenti, noi ci giriamo intorno, ci agitiamo, ci dimeniamo, corriamo via, tentando di sottrarre l’ ‘Io’ all’esperienza. Fingiamo di essere delle amebe e cerchiamo di proteggerci dalla vita dividendoci in due. La salute mentale, l’interezza e l’integrazione risiedono nella comprensione che non siamo divisi, che l’uomo e la sua esperienza presente sono una cosa sola, e che impossibile trovare un ‘Io’ o una psiche separati.
Sino a quando continuerò a pensare d’essere separato dalla mia esperienza vi sarà confusione e scompiglio. Per questo non avrò né consapevolezza né comprensione dell’esperienza, e quindi nessuna vera possibilità di assimilarla. Per capire quest’istante non devo cercare di separarmene, ma devo esserne consapevole con tutto il mio essere. E ciò, al pari dal trattenermi dal non respirare per dieci minuti, non è qualcosa che dovrei fare. In realtà è la sola cosa che posso fare. Qualsiasi altra cosa è la follia di tentare l’impossibile.
Per capire la musica dobbiamo ascoltarla. Ma finché pensiamo: “Io sto ascoltando questa musica” non la sentiamo. Per capire la gioia o la paura dobbiamo esserne consapevoli in modo totale e indiviso. Finché le diamo un nome e diciamo: “Sono felice”, oppure: “Ho paura”, non ne siamo coscienti. Paura, dolore, afflizione, noia restano problemi se non li capiamo, ma il capirli richiede una psiche semplice e indivisa. E’ certamente questo il significato dello strano detto: “Se il tuo occhio è semplice anche tutto il tuo corpo è illuminato”.
L’istante meraviglioso
Stai ascoltando una canzone. All’improvviso ti chiedo: “Chi sei in questo momento?” Come risponderai con spontaneità e immediatezza alla domanda, senza smettere di ascoltare per trovare le parole? Se la domanda non ti distrae dall’ascolto risponderai canticchiando la canzone. Se la domanda ti ha sorpreso risponderai: “Chi sei tu in questo momento?”. Ma se inizi a pensare, cercherai di dirmi qualcosa non su questo momento, ma sul passato. Verrò informato sul tuo nome, il tuo indirizzo, i tuoi affari e la tua storia personale. Ma ti ho chiesto chi sei, non chi eri. In effetti essere consapevoli della realtà, del presente che è vissuto, significa scoprire che in ogni istante l’esperienza è tutto. Non c’è nient’altro oltre a essa: nessuna esperienza di un ‘tu’ che sperimenta l’esperienza.
Anche nei più evidenti momenti di autocoscienza, il ‘sé’ di cui siamo consci è sempre un qualche particolare sentimento o sensazione: di tensione muscolare, caldo o freddo, dolore o irritazione, respiro o sangue che pulsa. Non c’è mai la sensazione di ciò che sente la sensazione, proprio come non c’è alcun senso o possibilità nella nozione dell’odorarsi il naso o del baciarsi le labbra.
Nei periodi di felicità o di piacere, di solito siamo abbastanza pronti a prendere coscienza dell’istante e a lasciare che l’esperienza sia tutto. In quei momenti ‘dimentichiamo noi stessi’ e la mente non compie alcun tentativo di dividersi da se stessa. Di separarsi dall’esperienza. Ma con l’arrivo del dolore fisico o emotivo, effettivo o previsto, ha inizio la frattura e il cerchio si allarga sempre di più.
Non appena diventa chiaro che l’ ‘Io’ non può assolutamente sfuggire alla realtà del presente, perché l’ ‘Io’ non è altro che ciò che conosco ora, questo scompiglio interno deve cessare. Non resta alcun’altra possibilità se non la presa di coscienza del dolore, della paura, della noia o della sofferenza nella stessa maniera completa in cui si è coscienti del piacere. L’organismo umano ha le più meravigliose facoltà di adattamento sia al dolore fisico sia a quello psichico. Ma queste possono funzionare appieno solo quando il dolore non viene continuamente ristimolato da questo sforzo interiore di liberarsene, di separare l’ ‘Io’ dalla sensazione. Lo sforzo crea una tensione in cui il dolore aumenta. Ma quando la tensione cessa, mente e corpo incominciano ad assorbire il dolore come l’acqua reagisce a un colpo o a un taglio.
C’è un’altra storia di un saggio cinese al quale fu chiesto: “Come sfuggiremo al calore?!, intendendo, naturalmente, il calore della sofferenza. Egli rispose: “Andate dritti in mezzo al fuoco”. “Ma allora come sfuggiremo alla fiamma che brucia?” “Nessun altro dolore vi affliggerà più!” Non è necessario andare fino in Cina. Troviamo la stessa idea nella Divina Commedia, dove Dante e Virgilio scoprono che la via d’uscita dall’inferno sta proprio al centro di esso.
Nei momenti di grande gioia di regola non ci fermiamo a pensare: “Sono felice”, oppure: “Questa è gioia”. Di solito non ci arrestiamo per pensare pensieri del genere sino a quando la gioia non abbia superato il suo culmine e non ci prenda l’ansia di vederla sparire. In quei momenti siamo talmente consapevoli dell’istante da non fare alcun tentativo di confrontare l’esperienza di esso con altre esperienze. Perciò non gli diamo alcun nome, perché i nomi che non siano semplici esclamazioni si basano su paragoni. ‘Gioia’ è distinto da ‘dolore’ per contrasto, dal porre a confronto uno stato d’animo con un altro. Se non avessimo mai conosciuto la gioia ci sarebbe impossibile identificare il dolore come dolore.
Ma nella realtà non possiamo confrontare la gioia col dolore. Il confronto è possibile solo con il rapidissimo alternarsi di due stati d’animo e non possiamo continuare a passare dall’autentico sentimento di gioia a quello di dolore e viceversa come possiamo passare con lo sguardo da un cane a un gatto. Possiamo solo confrontare il dolore con il ricordo della gioia, che non è affatto la stessa cosa della gioia vera e propria.
Come le parole, anche i ricordi non riescono mai a ‘cogliere’ veramente la realtà. I ricordi sono un po’ astratti, essendo una conoscenza su cose piuttosto che di cose. Il ricordo non afferra mai l’essenza, l’intensità presente, la realtà concreta di un’esperienza. E’, per così dire, il cadavere di un’esperienza, da cui è scomparsa la vita. Ciò che conosciamo attraverso il ricordo lo conosciamo solo di seconda mano. I ricordi sono morti perché sono fissi. Il ricordo della nonna morta può solo ripetere ciò che la nonna era. Ma la nonna reale, presente poteva sempre fare o dire qualcosa di nuovo, e non eravamo mai assolutamente certi di ciò che avrebbe fatto un momento dopo.
Vi sono allora due modi di capire un’esperienza. Il primo è confrontarla con i ricordi di altre esperienze, e così darle un nome e definirla. Ciò significa interpretarla in conformità a ciò che è morto e al passato. Il secondo è prenderne coscienza così com’è, come quando, nell’intensità della gioia, dimentichiamo il passato e il futuro, e lasciamo che il presente sia tutto, e così non ci fermiamo neppure a pensare: “Sono felice”.
Entrambi i modi di conoscere hanno le loro utilizzazioni. Essi però corrispondono alla differenza tra il conoscere una cosa con le parole e il conoscerla direttamente. Un menù è molto utile, ma non sostituisce il pranzo. Una guida è uno strumento mirabile, ma è difficile raffrontarla al paese che descrive.
Quando dunque cerchiamo di capire il presente confrontandolo con dei ricordi non lo capiamo così a fondo come quando ne siamo coscienti senza confrontarlo. Eppure è proprio questo il modo in cui di solito ci accostiamo alle esperienze spiacevoli. Invece di prendere coscienza come sono, cerchiamo di trattarle in termini di passato. La persona spaventata o che si sente sola comincia subito a pensare: “Sono spaventato”, oppure “Mi sento tanto solo”.
Naturalmente questo è un tentativo di evitare l’esperienza. Non vogliamo prendere coscienza di questo presente. Ma non possiamo sottrarci al presente, la nostra solo via di scampo è nei ricordi. Qui ci sentiamo al sicuro, perché il passato è ciò che è stabile e conosciuto – ma anche, naturalmente, ciò che è morto. Così, per cercare di sfuggire, poniamo, alla paura tentiamo subito di separarcene e di ‘fissarla’ interpretandola in termini di ricordo, in termini di ciò che è già stabile e noto. In altre parole, cerchiamo di adattarci al presente misterioso confrontandolo col passato (ricordato), dandogli un nome e ‘identificandolo’.
Tutto questo andrebbe benissimo se cercassimo di sottrarci a qualcosa a cui possiamo sottrarci. E’ un procedimento utile per sapere quando metterci al riparo dalla pioggia. Ma non ci insegna a vivere con cose alle quali non possiamo sottrarci, che sono già parte di noi stessi. Il nostro corpo non elimina i veleni conoscendone il nome. Cercare di controllare la paura o la depressione o la noia dando a esse un nome è come far ricorso alla superstizione della fiducia nelle maledizioni e nelle invocazioni.
E’ facile vedere perché la cosa non funziona. E’ chiaro che cerchiamo di conoscere, denominare e definire la paura al fine di renderla ‘oggettiva’ ossia separata dall’ ‘Io’. Ma perché cerchiamo di separarci dalla paura? Perché abbiamo paura. In altre parole, la paura cerca di separarsi da se stessa, come se si potesse combattere il fuoco col fuoco. Ma non è tutto. Più ci abituiamo a capire il presente in termini di ricordo, l’ignoto con il noto, il vivo con il morto, più la vita diventa arida e fossilizzata, senza gioia e frustrata. Così protetto contro la vita, l’uomo diventa una specie di mollusco incrostato in un duro guscio di ‘tradizione’, per cui quando infine la realtà irrompe, come deve fare, si scatena la marea della paura soffocata.
Se invece prendiamo coscienza della paura, ci rendiamo conto che, siccome questo sentimento siamo noi stessi, non c’è via di scampo. Vediamo che chiamarlo ‘paura’ ci dice poco o nulla su di esso, perché il confronto e la denominazione si basano non già sull’esperienza passata, ma sul ricordo. Allora non abbiamo altra scelta che prenderne coscienza con tutto il nostro essere come esperienza completamente nuova. In realtà ogni esperienza è in questo senso nuova, e in ogni istante della vita siamo in mezzo al nuovo e all’ignoto. A questo punto riceviamo l’esperienza senza resistervi o denominarla, e scompare interamente il senso del conflitto fra l’ ‘Io’ e la realtà presente.
Per la maggior parte di noi è un conflitto che continua a tormentarci perché la nostra vita è un solo lungo sforzo per resistere all’ignoto, al presente reale in cui viviamo che è l’ignoto nel pieno della sua venuta all’essere. Vivendo così non impariamo mai veramente a viverci insieme. In ogni momento siamo cauti, esitanti, sulla difensiva. Ed è assolutamente inutile, perché volenti o nolenti la vita ci sospinge nell’ignoto e resistervi è vano ed esasperante come cercare di nuotare contro corrente in un torrente impetuoso.
L’arte di vivere in questo ‘impiccio’ non è né un incurante lasciarsi trasportare né, d’altro lato, un timoroso aggrapparsi al passato e al noto. Si tratta invece di essere completamente sensibili a ogni istante, di considerarlo come assolutamente nuovo e unico, di avere la mente aperta e totalmente ricettiva.
Questa non è una teoria filosofica, ma una sperimentazione. Si deve fare la sperimentazione per capire come essa ponga in azione complessivamente nuove facoltà di adattamento alla vita, di un vero assorbimento del dolore e dell’insicurezza. Descrivere come operi questo assorbimento è altrettanto difficile che spiegare il battito del proprio cuore o la formazione dei geni. Ma la mente ‘aperta’ lo fa come la maggior parte di noi respira: senza essere capaci di spiegarlo. Il principio che ne è alla base è qualcosa di simile al judo: il delicato (ju) modo (do) di padroneggiare una forza avversa arrendendovisi.
Il mondo naturale ci dà molti esempi della grande efficacia di questo metodo. La filosofia cinese di cui lo stesso judo è espressione – il Taoismo – ha richiamato l’attenzione sul potere che ha l’acqua di superare ogni ostacolo con la sua delicatezza e duttilità. Ha mostrato come il flessibile salice sopravviva nella tormenta al rigido pino, perché mentre i duri rami del pino accumulano neve sino a spezzarsi, gli elastici rami del salice si piegano sotto il suo peso, la fanno cadere e tornano a drizzarsi. Se mentre nuotiamo siamo presi in una forte corrente, opporvisi è funesto. Dobbiamo nuotare con essa e accostarci gradatamente alla riva. Chi cade dall’alto con le membra rigide se le spezza, ma se le rilascia come fa il gatto cade senza pericolo. Un edificio senza una struttura ‘elastica’ crolla facilmente nell’uragano o nel terremoto, e un’automobile non ammortizzata da pneumatici e balestre si sfascerebbe subito sulla strada.
La psiche ha esattamente le stesse facoltà, in quanto ha elasticità e può assorbire i colpi, come l’acqua o il cuscino. Ma questo cedere a una forza avversa non è affatto fuggire: Una massa d’acqua non fugge quando la spingiamo; semplicemente cede nel punto di applicazione della spinta e ci circonda la mano. L’ammortizzatore non cade come un birillo quand’è colpito; cede e continua a rimanere nello stesso posto. Fuggire è soltanto la difesa di qualcosa di rigido contro una forza preponderante. Perciò il buon ammortizzatore ha non solo ‘elasticità’, ma anche stabilità o ‘peso’.
Anche il peso è una funzione della psiche e si manifesta nell’assai travisato fenomeno dell’ozio. E’ abbastanza significativo che la gente nervosa e frustrata sia sempre indaffarata anche quando è inattiva, essendo quest’inattività l’ ‘ozio’ della paura, non del riposo. Ma il corpo-mente è un sistema che conserva e accumula energia. Sebbene il farlo a rigore sia oziare. Quando l’energia è immagazzinata è lietissima di muoversi, ma muoversi con destrezza lungo la linea di minor resistenza. Quindi non solo la necessità, ma anche l’ozio è il padre dell’inventiva. Possiamo osservare i movimenti calmi, ‘pesanti’ dell’abile lavoratore intento a qualche arduo compito. Il provetto alpinista usa la gravità persino per procedere contro la gravità: con passi lenti, lunghi e pesanti: Sembra che accolga il pendio, come fa una barca a vela contro il vento.
Alla luce di questi princìpi come fa la psiche ad assorbire la sofferenza? Scopre che il resistere e il cercare scampo – il procedimento dell’Io – è una mossa falsa. Non c’è scampo al dolore, e il resistervi come difesa non fa che peggiorarlo: l’intero sistema stride sotto l’urto. Constatando l’impossibilità di questa linea d’azione deve agire in conformità alla propria natura: restare stabile e assorbire.
Restare stabili significa non cercare di separarci da un dolore perché sappiamo di non poterlo fare. Fuggire dalla paura è paura, combattere il dolore è dolore, cercare d’essere coraggiosi è provare spavento. Se la psiche è nel dolore, la psiche è dolore. Chi pensa non ha altra forma che il proprio pensiero. Non c’è via di scampo. Ma sino a quando non ci rendiamo conto dell’inseparabilità di pensatore e pensiero continuiamo a cercare scampo.
E’ naturale allora che la conseguenza di tutto ciò sia l’assorbimento. Non richiede sforzo; la psiche lo fa da sé. Vedendo che non può sfuggire al dolore, la psiche cede a esso, lo assorbe e diviene cosciente del dolore puro e semplice, senza un ‘Io’ che lo senta o vi resista. Sperimenta il dolore nello stesso modo completo, senza autocoscienza, con cui sperimenta il piacere. Il dolore è la natura di questo momento presente, e solo in questo momento io posso vivere.
A volte, quando cessa la resistenza, il dolore semplicemente scompare o diventa un malessere facilmente sopportabile. Altre volte rimane, ma la mancanza di una qualsiasi resistenza porta a un modo di avvertire il dolore così inconsueto da essere difficilmente descrivibile. Il dolore cessa di essere problematico. Lo sento, ma non provo alcun impulso a sbarazzarmene perché ho scoperto che il dolore e lo sforzo per separarmene sono una cosa sola. Voler sfuggire al dolore è il dolore. Quando si scopre questo, il desiderio di sottrarvisi si ‘fonde’ col dolore stesso e svanisce.
Ignorando per il momento l’aspirina, non puoi togliere la testa dal mal di testa come puoi togliere la mano dalla fiamma. ‘Tu’ uguale ‘testa’ uguale ‘male’. Quando ti accorgi veramente che sei il dolore, il dolore cessa di essere un movente, perché non c’è nessuno da muovere. Perde veramente ogni importanza. Fa male e basta.
Questo però non è un esperimento da tenere in riserva, come uno stratagemma per i momenti di crisi. E’ un modo di vivere. Significa essere consapevoli, svegli e sensibili al momento presente, ed esserlo sempre, in qualsiasi azione e relazione, cominciando da quest’istante. A sua volta ciò dipende dalla constatazione che in realtà non abbiamo altra scelta se non quella di essere consapevoli – perché non possiamo separarci dal presente né possiamo definirlo. Certo, possiamo rifiutarci di ammetterlo, ma solo al prezzo dell’enorme e vano sforzo di passare l’intera vita resistendo all’inevitabile.
Quando lo si è capito, è una vera assurdità dire che c’è una scelta o un’alternativa tra questi due modi di vivere, tra il resistere alla corrente in un panico sterile e l’aprire gli occhi a un mondo nuovo, trasformato e sempre prodigiosamente nuovo. La chiave sta nel capire. Se ci chiediamo come farlo, con quale tecnica o metodo, con quali passi o regole, siamo completamente fuori strada. I metodi servono a creare cose che non esistono ancora. Qui si tratta di capire qualcosa che è – il momento presente. Questa non è una disciplina psicologica o spirituale per il miglioramento di sé. E’ semplicemente il prendere coscienza dell’esperienza presente, il rendersi conto che non possiamo né definirla né separarcene. Non c’è altra regola che il: ‘Guarda!’.
Non è soltanto un sentimento poetico dire che, con la mente così aperta, guardiamo in un mondo nuovo come nel primo giorno della creazione “quando gli astri del mattino cantavano insieme e tutti i figli di Dio gridavano di gioia”. Cercando di capire ogni cosa in termini di ricordo, passato e parole, siamo stati, per così dire, col naso sulla guida per la maggior parte della vita e non abbiamo mai guardato il panorama. La critica mossa da Whitehead all’istruzione tradizionale si attaglia perfettamente a tutto il nostro modo di vedere:
Il nostro sistema scolastico è troppo esclusivamente libresco… Nel Paradiso Terrestre, Adamo ha visto gli animali prima di aver dato loro un nome; nel sistema educativo tradizionale i fanciulli danno i nomi agli animali prima di averli visti.
(A.N. Whitehead, La scienza e il mondo moderno, Bompiani, Milano, 1945.)
In senso lato, denominare significa interpretare l’esperienza mediante il passato, tradurla in termini di ricordo, fissare l’ignoto nel sistema del conosciuto. L’uomo civilizzato non conosce quasi altri modi di capire le cose. Ogni persona, ogni cosa dev’essere etichettata, numerata, attestata, registrata, classificata. Ciò che non è classificato è irregolare, imprevedibile e pericoloso. Senza il passaporto, il certificato di nascita o di appartenenza a qualche nazione, la propria esistenza non viene riconosciuta. Se non sei d’accordo con i capitalisti, questi ti chiamano comunista e viceversa. La persona che non accetta nessuno dei due punti di vista diventa ben presto incomprensibile.
Che vi sia un modo di considerare la vita che prescinda dalle varie concezioni, credenze, opinioni e teorie è, tra tutte le possibilità, la più remota dalla mente moderna. Se un siffatto punto di vista esiste, esso può esistere solo nel vacuo cervello di un deficiente. Abbiamo l’illusione che l’ordine dell’intero universo sia mantenuto dalle categorie del pensiero umano, nel timore che, se non ci atteniamo a queste con estrema tenacia, tutto scompare nel caos.
Dobbiamo ripetere: memoria, pensiero, linguaggio e logica sono essenziali nella vita umana. Sono però solo una metà della salute mentale. Ma una persona, una società che sia sana di mente soltanto a metà è insana. Considerare la vita senza le parole non significa perdere la capacità di formare le parole: di pensare, ricordare, progettare. Tacere non significa perdere la lingua. Al contrario, solo attraverso il silenzio possiamo scoprire qualcosa di cui parlare. Chi parlasse incessantemente, senza fermarsi per considerare e ascoltare, si ripeterebbe ad nauseam.
Avviene la stessa cosa per quanto riguarda il pensiero, che in realtà è un parlare silenzioso. Di per sé non è aperto ad alcunché di nuovo perché le sue sole novità non sono altro che riordinamenti di parole e idee. C’è stato un tempo in cui il linguaggio si arricchiva costantemente di parole nuove, un tempo in cui gli uomini, come Adamo, vedevano le cose prima di dare a esse un nome. Oggi quasi tutte le parole nuove sono combinazioni di vecchie parole, perché non pensiamo più in modo creativo. Con ciò non intendo dire che dovremmo impegnarci tutti in invenzioni e scoperte rivoluzionarie. E’ questa la facoltà – sempre rara – di coloro che riescono a vedere l’ignoto e a interpretarlo. Per la maggior parte di noi l’altra metà della salute mentale sta semplicemente nel vedere l’ignoto e goderne, proprio come possiamo godere la musica senza conoscere né come è scritta né come il corpo l’ascolta.
Certo, il pensatore rivoluzionario può andare al di là del pensiero. Sa che quasi tutte le idee migliori gli vengono quando il pensiero si arresta. Può accadere che abbia compiuto uno sforzo sovrumano per capire un problema secondo i vecchi modi di pensare solo per constatare l’impossibilità di riuscirci. Ma quando il pensiero si arresta esausto, la mente è aperta alla visione del problema così com’è – non come è verbalizzato – e lo comprende immediatamente.
Ma l’andare oltre il pensiero non è riservato agli uomini di genio. E’ accessibile a tutti noi nella misura in cui “il mistero della vita non è un problema da risolvere, ma una realtà da sperimentare”. E’ dato a molti l’essere indovini, ma a pochi l’essere profeti. Molti possono ascoltare musica, pochi eseguirla e comporla. Ma non possiamo neppure ascoltare se riusciamo solo a udire in termini di passato. Che cosa possiamo capire di una sinfonia di Mozart se il nostro orecchio è intonato soltanto alla musica dei tamtam? Potremmo cogliere i ritmi, ma quasi nulla dell’armonia e della melodia. In altre parole, non riusciremo a scoprire un elemento musicale essenziale. Per essere in grado di ascoltare, e più ancora di scrivere, una sinfonia del genere gli uomini hanno dovuto scoprire nuovi rumori: le vibrazioni della corda di minugia, il suono dell’aria in una canna, il ronzio del pizzicato. Hanno dovuto scoprire l’intero mondo dell’armonia, come qualcosa di completamente diverso dalla percussione.
Se riesco soltanto a concepire la percussione, non posso apprezzare l’armonia. Se la pittura è per me solo una maniera di fare fotografie a colori senza la macchina fotografica, un paesaggio cinese mi sembrerà una sciocchezza. Non apprendiamo niente di veramente importante se possiamo spiegarlo completamente con l’esperienza passata. Se fosse possibile capire ogni cosa in base a quanto già conosciamo, potremmo trasmettere a un cieco il senso del colore semplicemente ricorrendo al suono, al gusto, al tatto o all’odorato.
Se ciò è vero per le varie arti e scienze, è mille volte più vero quando giungiamo alla comprensione della vita in senso lato e vogliamo avere qualche conoscenza della realtà ultima, o Dio. E’ certamente assurdo andare alla ricerca di Dio in base all’idea preconcetta di ciò che Dio è. Questo modo di cercare equivale a trovare ciò che già sappiamo, perciò è così facile illudersi sulle varie forme di esperienze o visioni ‘sovrannaturali’. Credere in Dio e cercare il Dio in cui si crede non è che cercare conferma a un’opinione. Chiedere la rivelazione della volontà divina e poi sottoporla a ‘verifica’ riferendola ai nostri preconcetti standard morali significa non prendere la richiesta sul serio. Cercare Dio in questo modo non è altro che la pretesa dell’autorità e della certezza assolute su ciò in cui crediamo in ogni caso, della garanzia che l’ignoto e il futuro saranno la continuazione di ciò che vogliamo conservare del passato – un più ampio e migliore baluardo per l’Io. Ein feste Burg!
Se siamo aperti solo a scoperte che si accordino con quanto già conosciamo, possiamo benissimo restare chiusi. Ecco perché in pratica ci servono così poco le meravigliose realizzazioni della scienza e della tecnologia. E’ inutile che riusciamo a prevedere e controllare il futuro corso degli eventi se non sappiamo vivere nel presente. E’ inutile che i medici prolunghino la vita se poi trascorriamo il tempo concessoci in più nell’ansia di vivere ancora più a lungo. E’ inutile che gli ingegneri progettino mezzi di trasporto più veloci e più comodi se poi ci limitiamo a scegliere e a capire i nuovi luoghi che visitiamo in base ai vecchi pregiudizi. E’ inutile acquisire la potenza dell’atomo se poi dobbiamo continuare nell’andazzo di massacrare la gente.
Strumenti del genere, al pari degli strumenti del linguaggio e del pensiero, sono veramente utili agli uomini solo se essi sono ben desti; se non si perdono nel paese dei sogni del passato e del futuro, ma sono in stretto contatto con quel punto dell’esperienza in cui la realtà può essere scoperta da sola: questo istante. Qui la vita è attiva, vibrante, vivida e presente, con profondità che abbiamo appena cominciato a esplorare. Ma per vedere e capire appieno questo la mente non dev’essere divisa in ‘Io’ e ‘questa esperienza’. L’istante dev’essere ciò che è sempre: tutto ciò che sei e che sai. In questa casa non c’è posto per te e per me!